Le avventure in musica di Sounds & Grooves proseguono nella 17° Stagione di RadioRock.TO The Original
Nell’undicesimo episodio stagionale di Sounds & Grooves troverete il mio omaggio a Wayne Shorter, un piccolo spaccato dell’era punk e tante novità
Torna l’appuntamento quindicinale di Sounds & Grooves che per il 17° anno consecutivo impreziosisce (mi piace pensarlo) lo straordinario palinsesto di www.radiorock.to. A pensarci è incredibile che sia passato già così tanto tempo da quando abbiamo iniziato questa folle ma fantastica avventura. Come (credo) già sapete, la nostra podradio è nata per dare un segnale di continuità con il passato, con quella meraviglia che Franz Andreani, Marco Artico, Flavia Cardinali, Massimo Di Roma, Michele Luches, Aldo Semenuk, Giampiero Crisanti, Gianpaolo Castaldo avevano creato e a cui, nel mio piccolo, ho provato a dare un contributo dal 1991 al 2000. Sappiamo tutti benissimo che la Radio Rock in FM come la intendevamo noi è sparita da almeno due decenni, ma in tutti questi anni di podcast sul web abbiamo cercato di tenere accesa quella fiammella per poi tentare di moltiplicarla, facendola diventare un faro di emozioni e qualità musicale. Perché la passione e la voglia di fare radio, la voglia di ascoltare e di condividere la musica di qualità, nonostante tutto, non ci è mai passata. Questa creatura dopo più di 3 lustri continua orgogliosamente a remare controcorrente, cercando quella libertà in musica che nell’etere è ormai diventata una mosca bianca, ed esprimendo con forza la passione per la condivisione, per la ricerca, per l’approfondimento. Non dobbiamo aderire ad una cieca linea editoriale che ormai spinge esclusivamente il pulsante play dei servizi di streaming, ma ci lasciamo guidare semplicemente dal nostro cuore e dalla nostra passione. Fulvio Savagnone, Marco Artico, Giampiero Crisanti, Franz Andreani, Flavia Cardinali, Francesco Cauli, Ivan Di Maro, Massimo Santori aka Moonchild, Maurizio Nagni ed io proviamo ogni giorno a coinvolgervi con i nostri podcast regolari e con le rubriche tematiche di approfondimento, sperando di farvi sentire sempre di più parte di questa fantastica avventura.
Nel’undicesimo viaggio della nuova stagione troverete il mio personale omaggio a un grande del jazz (e non solo) come Wayne Shorter, con brani di Weather Report e Miles Davis. Continueremo quella piccolissima panoramica su quella straordinaria avventura del punk a NYC che faceva capo al CBGB insieme a Ramones, Dead Boys e Talking Heads. Parleremo dei Wire e del progetto del loro bassista Graham Lewis chiamato Elegiac, riscopriremo il post rock britannico degli anni ’90 con Bark Psychosis e Moonshake, la nuova ondata psichedelica con The Black Angels e un incattivito Pete Townshend d’annata. Ascolteremo anche tre delle novità più interessanti di questo inizio 2023: il nuovo ricchissimo Algiers, la collaborazione tra Graham Coxon dei Blur e Rose Elinor Dougall chiamata The Waeve e il secondo di una delle più promettenti cantautrici britanniche come Anna B Savage. Il tutto, come da ben 16 anni a questa parte, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.
Seguite il nostro hashtag: #everydaypodcast
Download, listen, enjoy!!!
Prima di partire con questo viaggio in musica potete effettuare il download del podcast anche nella versione a 320 kb/s semplicemente cliccando sul banner qui sotto.

Iniziamo il podcast celebrando la vita e le opere di uno straordinario musicista. Wayne Shorter ci ha accompagnato tra molte collaborazioni creando un linguaggio estremamente personale. Nato come “discepolo” di John Coltrane, Shorter ha fatto parte dello storico quintetto di Miles Davis dal 1964 al 1970 vivendo e contribuendo alla nascita del jazz elettrico. Il passaggio graduale al sax soprano e la sinergia sempre più stretta con il tastierista austriaco Joe Zawinul porta alla creazione dei Weather Report. Il gruppo in qualche modo rivoluziona il linguaggio del jazz consacrando, anche con spunti funky, la svolta elettrica lanciata da Miles Davis, anche se sarà anche il trampolino di lancio delle forme più semplici e piene di inutili tecnicismi della nascente musica fusion.
Dopo sei album dove il nucleo originario è formato dalla coppia Shorter-Zawinul con l’avvicendamento di vari batteristi e dei bassisti Miroslav Vitous e Alphonso Johnson, i Weather Report nel 1976 per le registrazioni di Black Market accolgono il bassista prodigio Jaco Pastorius (successivamente la formazione diventerà stabile con l’ingresso di Peter Erskine alla batteria) dando vita al segmento di carriera più bagnato dal successo. Il successivo Heavy Weather esce nel 1977 ed è subito un grande successo, vendendo quasi trecentomila copie appena dopo la pubblicazione. Il brano di apertura del disco (e del podcast), “Birdland”, è dedicato al locale newyorkese dove negli anni cinquanta si esibivano i jazzisti più famosie diventa subito uno standard, ripreso nel corso degli anni da tantissimi altri artisti tra cui Maynard Ferguson, i Manhattan Transfer e Quincy Jones.

Nella puntata scorsa avevo promesso che avrei parlato di alcuni gruppi che hanno fatto la storia della scena newyorkese nella seconda metà degli anni ’70. Andiamo quindi a ripercorrere le prime orme dei Talking Heads. David Byrne insieme alla sezione ritmica (che poi diventerà coppia nella vita) formata da Chris Frantz (batteria) e Tina Weymouth (basso), si incontrano alla Rhode Island School Of Design e dopo essersi trasferiti a NYC, fanno un rodaggio estremamente impegnativo sul difficile palco del locale simbolo della scena punk dell’epoca: il CBGB di cui abbiamo parlato ampiamente nello scorso episodio. Stranamente la compostezza intellettuale della band, teoricamente così poco punk, colpì a fondo facendo diventare Byrne e compagni alfieri del neonato movimento new wave.
In realtà del punk rimane solo l’impianto scarno e una sorta di alienazione urbana. Talking Heads: 77 è il loro album di esordio, dove Byrne mette in campo a modo suo tutte le sue suggestioni sonore, dal funk alla psichedelia, dai ritmi martellanti alla semplicità dell’impianto sonoro. Non meno importanti sono le liriche che, nonostante l’apparente semplicità quasi frivola della musica, vanno a scavare nella profondità dell’animo umano. Sebbene il disco sia conosciuto per la trascinante “Psycho Killer” con il suo memorabile ritornello, l’album contiene molte altre prelibatezze, solo le prime di una carriera straordinaria.

Il podcast prosegue con un altro gruppo che ha fatto eccome la storia del rock. I Wire si formano a Londra nel 1976, in piena era punk, ma Colin Newman, fondatore della band, studente d’arte e grande amico di Brian Eno, riuscì a creare un suono unico, debitore solo in parte dello tsunami che si stava abbattendo sul mondo musicale in quei mesi. I quattro componenti del gruppo si diversificano per la loro formazione accademica. Non sono mai stati il tipico gruppo stradaiolo, ed il loro punk si mostra già dall’inizio mutante per le sue costruzioni oblique e stranianti che già dal secondo album Chairs Missing si rivolgeranno verso la new wave e verso una personale forma di psichedelia.
154 è il loro terzo lavoro, ultimo ad uscire per la Harvest, storica etichetta sussidiaria della EMI creata nel 1969 ed associata soprattutto ai Pink Floyd, fatto che aveva fatto dare loro dalla stampa britannica il nomignolo di “Punk Floyd”. E’ il disco della perfezione formale, dove la loro ritmica nervosa si apre in inaspettate aperture pop di avanguardia. Ascoltate la melodia perennemente in tensione di “I Should Have Known Better”. Dopo brusche rotture, ricongiungimenti e altre rotture, la band nel 2006 è tornata di nuovo in piena attività mantenendo un ottimo livello qualitativo e sfornando il loro ultimo Mind Hive nel 2020.

Nascendo ad Austin, nel Texas, il loro destino era segnato. Chi meglio dei Texani 13th Floor Elevators di Roky Erickson hanno definito il paradigma di “Rock psichedelico”? A portare avanti ai giorni nostri la bandiera di Austin come capitale mondiale della psichedelia sono Christian Bland (chitarra, voce, basso e percussioni), Alex Maas (voce, basso, sitar, tastiere), Stephanie Bailey (batteria e percussioni), Jake Garcia (chitarra) e Ramiro Verdooren (tastiere, basso e chitarra) che da poco ha preso il posto di Kyle Hunt. Insieme vanno sotto la ragione sociale di The Black Angels, gruppo attivo dal 2004 e che ha preso il proprio nome da “The Black Angel’s Death Song”, brano incluso nello storico debutto dei Velvet Underground.
Nel loro quinto album in studio intitolato Death Song e pubblicato nel 2017, il gruppo ha portato a compimento la quadratura della loro cupa psichedelia. Il disco è maturo e convincente, registrato dopo una lunga pausa durante la quale il gruppo aveva pubblicato due EP che avevano mostrato il proprio amore per il suono degli anni ’60. Le tracce sono costruite a più ampio respiro rispetto al precedente Indigo Meadow. L’influsso negativo della politica di Donald Trump ha portato Alex Maas a scrivere testi decisi e oscuri, che non lasciano spiragli di speranza. Il disco oscilla tra brani che condannano apertamente il capitalismo americano e altri più simbolici come la “Comanche Moon” scelta per la scaletta del podcast in cui Maas interpreta un disilluso nativo americano. Il 2022 ha visto tornare il gruppo in splendida forma con l’ottimo Wilderness Of Mirrors.

Nel 2015 ci aveva particolarmente colpito l’album di esordio degli Algiers, un trio formato ad Atlanta, Georgia dal cantante Franklin James Fisher, insieme al chitarrista Lee Tesche e al bassista Ryan Mahan. In realtà i tre si dividevano diversi altri strumenti infilando nelle 11 tracce del disco una serie di suoni estremamente interessanti tra battiti di mani e chitarre sferzanti, tra ritmi industrial ipnotici e scuri arricchiti da un incedere vocale gospel e un impianto new wave. Due anni dopo, l’atteso seguito intitolato The Underside Of Power fortunatamente aveva confermato tutto quello che di buono si era detto della band, che ha reso il suo suono ancora più poderoso grazie all’inserimento in pianta stabile dell’ex Bloc Party, Matt Tong, dietro ai tamburi. Il quartetto di Atlanta non ha affatto deluso le aspettative anche nel famoso “difficile” terzo album, anzi, forse con There Is No Year gli Algiers hanno messo nei solchi la loro versione più matura e consapevole. Il loro mettere in primo piano l’impegno sociale anticapitalista, antirazzista e antifascista li ha resi in qualche modo unici. La potente ed empatica voce soul di Fisher unita ad un impianto musicale che unisce post punk e gospel con precisi innesti di elettronica ha reso questo gruppo uno dei più importanti degli ultimi anni per emozioni e contenuti.
Cosa potevamo aspettarci nel 2023 dal quarto lavoro in studio? Shook mette in tavola tanta carne al fuoco, forse troppa. Tantissime le contaminazioni stilistiche e gli ospiti coinvolti, da Zach De La Rocha dei Race Against The Machine al veterano dell’hip-hop Big Rube, da Samuel T Herring dei Future Islands a LaToya Kent dei Mourning [A] BLKstar. Tra sferzate chitarristiche, elettronica, funk, il gruppo talvolta sembra perdere coesione e lucidità, ma talvolta riesce a ritrovare l’antica magia tanto dirompente quanto emozionale. “Bite Back”, il brano scelto per rappresentare un disco che (secondo il mio modesto parere) presenta luci ed ombre, parla della resistenza del movimento afroamericano, manovre psicologiche (PsyOps) e violenza della polizia e vede il frontman Franklin James Fisher avvicendarsi con due innovatori dell’hip hop contemporaneo: il rapper e produttore Backxwash, alias Ashanti Mutinta e Billy Woods, rapper di New York e fondatore dell’etichetta Backwood Studioz.

Abbiamo parlato nello scorso podcast della scena punk di NYC, in particolare quella il cui fulcro era il famoso locale CBGB. Come detto, lo tsunami del Punk si è abbattuto sulle terre emerse musicali nel 1976, devastando territori e radendo al suolo (o quasi) le ultime vestigia del progressive. L’epicentro del terremoto che generò cotanta onda fu negli Stati Uniti, in particolare il 7″ dei Ramones intitolato “Blitzkrieg Bop”, anche se poi fu geniale il caro buon vecchio Malcom McLaren ad esportare il movimento in UK creando i Sex Pistols che fecero sconquassi nel regno della perfida Albione. I Ramones, come detto pietra angolare del movimento punk, erano nati nel 1974 dall’incontro a Forest Hills, nel Queens (New York), del cantante Joey Ramone (Jeffrey Ross Hyman) con il chitarrista Johnny Ramone (John William Cummings), il bassista Dee Dee Ramone (Douglas Glenn Colvin) e il batterista Tommy Ramone (Tamás Erdélyi).
Ogni componente scelse Ramone come cognome d’arte proprio per dare maggior compattezza e dare l’idea di essere fratelli: stesso cognome, stesso look. L’essenza stessa del punk fu la continuazione del garage rock suonata da persone senza una grande preparazione musicale. L’idea che chiunque avrebbe potuto avere l’opportunità di salire su un palco, l’eliminazione (o quasi) della divisione musicisti-pubblico. I Ramones già dall’inizio suonavano brani scritti da loro stessi ed adattati ai loro limiti, con testi spesso autobiografici, oppure ironici, divertenti e privi di significati politici. Dalle prime serate disastrose al CBGB i quattro iniziarono a farsi un nome fino ad entrare in sala di registrazione per il primo album con un budget di appena 6000 dollari. L’esordio, intitolato semplicemente Ramones fu pubblicato il 23 Aprile 1976. La copertina è celebre tanto quanto il contenuto del disco stesso: nella foto realizzata da Roberta Bayley sono raffigurati i membri del gruppo appoggiati ad un muro poco distante dall’ingresso dello storico club CBGB, i quattro indossano jeans sdruciti e strappati al ginocchio, scarpe da tennis consunte, giubbotti in pelle nera, abbigliamento che li caratterizzerà. “Blitzkrieg Bop” viene scelto proprio come brano di apertura: l’inizio non solo di un disco ma di un genere destinato a sovvertire il mondo musicale e non solo.

Cleveland, cittadina industriale dell’Ohio che ha dato i natali a molte gloriose ed eccentriche formazioni. proprio qui, nel 1974, si formano i gloriosi Rocket From The Tombs, la cui formazione originale era composta da David Thomas (allora conosciuto come “Crocus Behemoth”) alla voce, Peter Laughner e Gene O’Connor (aka Cheetah Chrome) alla chitarra, Craig Willis Bell (aka Darwin Layne) al basso, e Johnny Madansky (aka Johnny Blitz) alla batteria. Allo scioglimento del gruppo Laughner e Thomas erano andati a formare i Pere Ubu, mentre Cheetah Chrome e Johnny Blitz avevano unito le forze con il cantante Stiv Bators (che aveva fatto un’apparizione sul palco durante l’ultimo show dei RFTT) per formare i Frankenstein, in seguito trasformati in Dead Boys, un gruppo punk rock più direttamente influenzato dal Detroit sound di Stooges e MC5.
L’ingresso nel gruppo del chitarrista ritmico William James Wilden (aka Jimmy Zero) e del bassista Jeff Halmagy (aka Jeff Magnum) insieme all’incoraggiamento proprio di Joey Ramone, il cantante dei Ramones, ha portato i Dead Boys a trasferirsi nel luglio del 1976 a New York City. Le loro incendiarie ed oltraggiose esibizioni dal vivo hanno avuto subito un riscontro positivo, portandoli spesso a suonare al CBGB (il proprietario del club Hilly Kristal fu per poco il loro manager) e nel 1977 a pubblicare l’album di debutto Young, Loud and Snotty, prodotto da Genya Ravan. La “Sonic Reducer” inserita in scaletta è spesso considerata uno dei grandi inni del punk ed è stata anche registrata recentemente (nel 2015) dai riformati Rocket From The Tombs nell’album Black Record. I Dead Boys si sciolsero subito dopo l’uscita del secondo album We Have Come for Your Children, scaricati dalla Sire Records. Bators formerà più tardi i Lords Of The New Church prima di morire il 3 giugno 1990 investito da un taxi nella Parigi in cui viveva già da un po’ assieme alla compagna Caroline Warren.

La fine degli anni ’70 rappresentano un periodo molto complicato per gli Who ed in particolare per Pete Townshend. I quattro ci avevano messo tre anni a preparare Who Are You e solo un mese dopo la pubblicazione del disco la morte di Keith Moon aveva fatto traboccare il vaso. Townshed, disilluso dal music business, in preda a problemi personali come l’inizio di un flirt con l’eroina e la fine del suo matrimonio è in una fase di pericolosa deriva. Metteteci anche il fatto che siamo in piena epoca punk-new wave e potete capire anche il senso di inadeguatezza del chitarrista compositore, ormai cosciente anche della profonda crisi della sua band di appartenenza. Townshend era uno dei membri della vecchia guardia che il punk avrebbe dovuto spazzare via ed era improvvisamente incerto sul suo posto nel futuro. Tutto questo confluì direttamente in Empty Glass, l’album solista che stava preparando da 18 mesi.
“L’ho chiamato “Bicchiere vuoto”, per l’idea che quando vai alla taverna – cioè da Dio – e chiedi il Suo amore – Lui è il barista – e ti dà da bere, quello che devi dargli è un bicchiere vuoto. Non ha senso dargli il tuo cuore se è già pieno; non ha senso andare da Dio se il tuo cuore è pieno di Cocktails”.
Secondo molti Roger Daltrey era estremamente arrabbiato con Townshend perché il compositore aveva usato le sue migliori canzoni per l’esordio solista e non per il nuovo album degli Who, e a posteriori non gli si può certo dar torto. Empty Glass è davvero un ottimo lavoro, probabilmente il suo album migliore. Durante la fase di scrittura del disco, con la morte di Moon ancora impressa nella mente di Townshend, il chitarrista lesse un’intervista in cui I giornalisti del NME Julie Burchill e Tony Parsons promuovevano il loro libro The Boy Looked At Johnny, in cui, in un velenoso sproloquio contro la promessa fallita del punk, riversavano la bile su chiunque era uscito da locali storici del punk come il CBGB, il 100 Club o il Roxy. In quell’intervista Tony Parsons parlò del defunto batterista degli Who dicendo: “Fanculo Keith Moon, stiamo meglio senza di lui. Un coglione decadente capace solo di buttare una Rolls-Royce in piscina. Se il rock and roll è questo, a chi serve?”. La rabbia provocata da quell’intervista spinse Townshend a scrivere l’incalzante e splendida “Jools And Jim”, una risposta caustica all’arroganza saccente degli accusatori di Moon e, per associazione, della stampa rock in generale. Il testo è implacabile, e passa dall’indignazione al vero e proprio disprezzo:
“Hai letto le cose che ha detto Julie? O il piccolo Jimmy con i capelli tinti di rosso? Non gliene frega un cazzo che Keith Moon sia morto. E’ esattamente quello che pensavo di aver letto?”.
A posteriori Townshend dirà: “Ero arrabbiato con Julie Burchill e Tony Parsons per aver detto nel loro libro che era un bene che Keith Moon fosse morto. Ma ne ho tratto una bella canzone. Devo dire subito che, ovviamente, col senno di poi mi sono reso conto di avere dei problemi, ma all’epoca mi piaceva molto il caos che stavo creando”.

Magari Graham Coxon, il chitarrista dei Blur, non è così eclettico e conosciuto per la sua produzione solista come il sodale nella band londinese Damon Albarn, ma la sua produzione non è affatto da sottovalutare. Stavolta, abbandonate le colonne sonore, Coxon ha stretto una proficua alleanza con la talentuosa folksinger Rose Elinor Dougall, fuoriuscita da tempo da quell’esperienza indie-pop chiamata Pipettes. L’incontro casuale tra i due nel backstage di un concerto di beneficenza in un piccolo club di Camden ha dato vita non solo ad un progetto musicale intrigante chiamato The Waeve ma anche ad un solido rapporto sentimentale. E l’alchimia anche a livello umano tra i due è uno dei segreti della solidità del progetto e dell’efficacia delle soluzioni musicali.
L’amore di entrambi per il folk scuro è solo uno degli ingredienti di un album che si dispiega in un registro vario di influenze e suggestioni. Devo essere sincero, il disco nella sua interezza non mi convince in toto, ma quando, e succede non così raramente, le cose girano a dovere tra suggestioni kraut, echi di antico trip-hop e un’intelligente spruzzata di pop, beh, allora è davvero un piacere per l’udito. Naturalmente Coxon non usa il suo strumento nel modo in cui lo usa nella band madre, ma padroneggia la sua sei corde assecondando gli umori delle tracce e la splendida e suadente voce della Dougall. Le suggestioni di “Drowning” sono sicuramente tra gli apici di un duo da seguire con grande attenzione.

Buffo che nelle pagine web italiane non ci sia praticamente spazio per Ted Milton. Eppure è un artista attivo già dagli anni ’60, prima come poeta, burattinaio e visionario, poi come sassofonista e fondatore dei Blurt, gruppo anarchico capace di unire post-punk e a no-wave con singulti jazz. Graham Lewis è sicuramente più conosciuto. Anche lui leader e outsider, bassista (e talvolta cantante) dalla mente brillante che ha contribuito non poco a rendere i Wire uno dei più grandi gruppi degli ultimi 50 anni di rock. Per formare una nuova band (che non sappiamo quanto sia un progetto estemporaneo o destinato ad avere un seguito) ai due si è aggiunto il compositore elettronico e sound artist Sam Britton, già capace in passato, insieme al cugino Ollie Bown, di farci rimanere a bocca aperte per le sue costruzioni sonore sotto il nome di Icarus.
Spesso e volentieri quando musicisti di questo calibro si uniscono, la somma delle parti ha spesso portato a cocenti delusioni se non a flop clamorosi. Ma fortunatamente, come nel caso (ad esempio) degli Springtime, l’intelligenza e il talento di Milton, Lewis e Britton ha condotto i neonati Elegiac ad incidere uno dei dischi più interessanti e non allineati del 2021. Beats seducenti, spoken word, interventi di sax, innesti dub, il tutto frullato da tre musicisti dalla enorme personalità che rendono brani come la “One Two” inserita in scaletta come diamanti grezzi e dalla inestimabile suggestione. Il loro album eponimo è senza dubbio uno dei lavori più intriganti usciti negli ultimi anni.

La londinese Anna B Savage nello straordinario esordio intitolato A Common Turn aveva messo a nudo le vulnerabilità di ognuno di noi, più o meno nascoste, e le aveva espresse con sussurri e potenza in 10 tracce composte da disarmante sincerità, tensioni e rilasci, ansie e catarsi. La recensione che ho avuto il privilegio di scrivere per OndaRock terminava così: “Non possiamo sapere come proseguirà la sua carriera, fare previsioni in campo musicale è sempre estremamente difficile e spesso si va incontro a brutte figure, ma questo è senza dubbio un esordio ammaliante”. C’era dunque una giustificata e alta aspettativa per il secondo lavoro della cantautrice britannica dopo l’uscita lo scorso anno di un EP intitolato These Dreams.
Fortunatamente i dubbi della vigilia sono stati dissipati dalla pubblicazione, qualche settimana fa, di in|FLUX. L’atteso ritorno della Savage conferma tutto quello che di buono si era detto sul suo conto. Stavolta a dare man forte alla songwriter c’è Mike Lindsay (Tunng) che la porta per mano come e più della precedente collaborazione con William Doyle ad un uso sapiente dell’elettronica. Anche qui, come nell’esordio, troviamo una disarmante sincerità, una vulnerabilità che si trasforma in una evidente e subitanea empatia. Troviamo di nuovo, ancora più consapevole, quel cambio di passo all’interno delle canzoni capace di stupire, l’alternanza tra momenti di quiete e quelli di intensità emotiva assoluta. In più c’è una nuova consapevolezza di artista e di essere umano che colpisce e convince come nella splendida “Say My Name”.
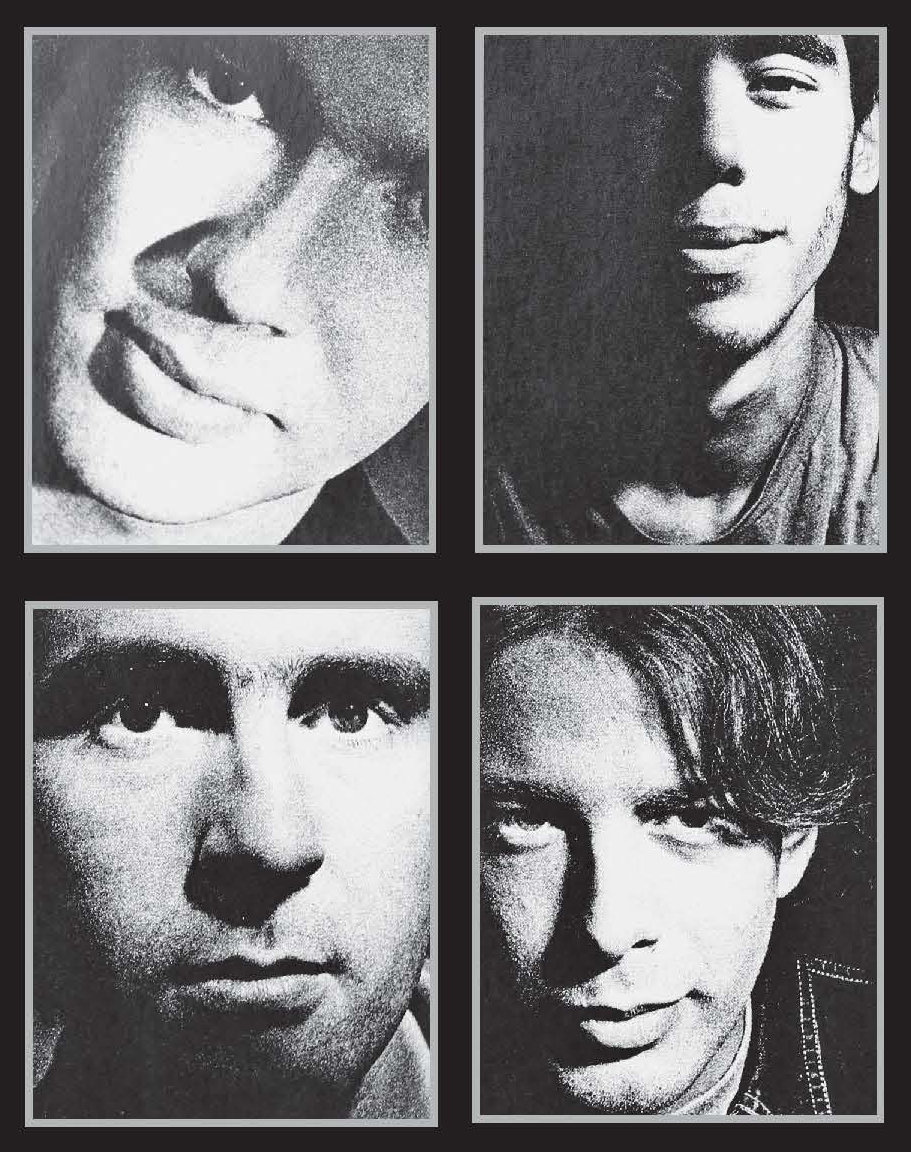
Ci avviciniamo alla fine del podcast con uno dei gruppi che più mi hanno colpito ed affascinato. Gli incubi e sogni dei Bark Psychosis hanno ispirato il critico Simon Reynolds a coniare uno dei termini più abusati in musica negli anni ’90, “post-rock”. Quando si parla della band di Graham Sutton (chitarra e voce), Daniel Gish (tastiere e piano), John Ling (basso e campionatore), e Mark Simnett (batteria e percussioni) la mente va sempre a vagare di notte nei sobborghi londinesi descritta in capitoli cinematici di rara suggestione onirica all’interno di quel tesoro nascosto chiamato Hex (1994). In copertina c’è la chiesa di St. John at Hackney vista di notte dai binari vicino alla stazione di Stratford, mentre sul terreno si stagliano le ombre dei componenti del gruppo, una zona che recentemente ha visto la costruzione del Parco Olimpico di Londra. I paesaggi industriali urbani, desolanti e crepuscolari che hanno ispirato l’artwork li ritroviamo tra i solchi del disco, in un’alternanza di silenzi e di miniature sonore, cortometraggi immaginifici.
Ma i Bark Psychosis, oltre ad Hex, hanno pubblicato anche diversi EP, e non tutti tratteggiano paesaggi sonori fatti di arpeggi di chitarra, tastiere avvolgenti e voce sussurrata. È il caso del 12″ intitolato Blue, che mantiene le atmosfere sognanti in un sottobosco fatto di suoni più dissonanti e movimentati. Graham Sutton tornerà a sorpresa solo 10 anni più tardi a rispolverare il nome Bark Psychosis con un album, Codename: Dustsucker, che provoca qualche sussulto per le atmosfere simili al predecessore pur non eguagliandone l’impatto sonoro ed onirico. Album che vede dietro i tamburi Lee Harris dei Talk Talk.

E se ho messo David Lance Callahan finalmente sul gradino più alto del podio raggruppando i suoi meravigliosi album solisti usciti tra 2021 e 2022 perdonandogli la lunghissima attesa, andiamo a riscoprire la sua vecchia band nonché uno dei gruppi cardine del post-rock britannico dei ’90. Sui Moonshake ho scritto un lungo articolo che ne ripercorre tutti i passi dagli esordi allo scioglimento. La band è stata formata da David Callahan e Margaret Fiedler nel 1990 scegliendo un nome che ne sancisse in maniera inequivocabile il legame con il krautrock (come abbiamo ascoltato prima, “Moonshake” non è altro che uno dei brani che compongono il seminale Future Days dei Can). I due leader trovano presto un loro equilibrio pur nella diversità dell’approccio alla materia sonora, la Fiedler più propensa a creare brani eterei e di atmosfera, Callahan a preferire un tessuto urbano più duro e spigoloso. Erano due facce della stessa medaglia, l’amore per le stesse bands (Can, My Bloody Valentine, PIL, Kraftwerk) espresso in maniera completamente differente. Un incontro esplosivo, una collisione tanto inevitabile quanto evocativa.
Eva Luna è il loro splendido esordio che si snoda in tredici meravigliose tracce dove Pop Group, Can, Public Image Ltd. e My Bloody Valentine si stringono in un caleidoscopico girotondo. I quattro mettono a fuoco un disco che, nei suoi tratti scarni e scheletrici, colpisce con le sue schegge new wave, con le sue argute bizzarrie, le poliritmie kraut, i fiati jazz e i suadenti innesti dub. Gli intricati ritmi di “Mig” Moreland e l’ipnotico basso dub di John Frenett, sono la migliore base possibile su cui possono partire brani fantastici come la torrenziale apertura di “Wanderlust”, I Moonshake, inseriti nel filone post-rock britannico, sono stati semplicemente uno dei gruppi più originali degli anni novanta il cui unico torto è stato di essere stati troppo facili per l’avanguardia e troppo intellettuali per la massa.

A fine podcast torniamo ad onorare la carriera di un musicista meraviglioso come Wayne Shorter e lo facciamo con uno degli album che hanno segnato a fuoco la storia della musica. Miles Davis prosegue idealmente la linea già tracciata con In A Silent Way registrando in soli tre giorni (il 19-20-21 agosto del 1969) uno dei capisaldi del jazz come Bitches Brew. Etichettare il disco come “jazz” è in realtà abbastanza riduttivo. Durante le registrazioni sono stati utilizzati diversi strumenti elettronici, come pianoforte, basso e chitarra elettrica, e la musica inizia a discostarsi dai ritmi abituali del jazz tradizionale, adottando un nuovo stile, fatto di improvvisazioni influenzate dalla musica funk. Miles è alla ricerca di nuove vibrazioni e raccoglie in studio un nutrito gruppo di musicisti convocati appositamente.
Nel 30th Street Studio di NYC ci sono Don Alias, Jack DeJohnette e Lenny White alla batteria, Juma Santos e Airto Moreira alle percussioni, Chick Corea, Joe Zawinul e Larry Young al piano elettrico, Dave Holland al basso acustico e Harvey Brooks a quello elettrico, John McLaughlin alla chitarra, Bennie Maupin al clarinetto basso e (last but not least) Wayne Shorter al sax soprano. L’improvvisazione collettiva viene guidata da Davis che impone al produttore Teo Macero di registrare tutto il materiale come fosse una lunga jam session, senza fermare mai il nastro. Lo stesso Macero aggiungerà alcuni effetti sonori in fase di post-produzione. Il risultato è un sensazionale flusso di idee, di atmosfere libere ed ipnotiche, dove i musicisti si lasciano andare in una sorta di rituale ancestrale, visualizzato anche dalla splendida copertina opera dell’artista Mati Klarwein. La “Miles Runs The Voodoo Down” che chiude il podcast, ispirata già nel titolo anche da Jimi Hendrix, è solo una delle meraviglie di un album che è entrato di diritto nella storia.
Un grazie speciale va, come sempre, a Franz Andreani per la sua passione, la gestione di questa banda di pazzi e per la splendida riorganizzazione del sito già attiva da qualche anno. A cambiare non è stata solo la versione grafica del sito, ma anche la “filosofia” della podradio, con le rubriche che vanno ad integrarsi nella programmazione regolare sotto l’hashtag #everydaypodcast. Sulla nostra pagina Facebook troverete quotidianamente ogni upload del sito e, ormai da tempo, è attivo anche lo splendido canale YouTube della Radio, una nuova formula senza interruzioni ne spot per ascoltare la vostra-nostra musica preferita. Iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo!
Nel prossimo episodio di Sounds & Grooves troverete un viaggio a ritroso verso le radici del power pop con Big Star e i discepoli scozzesi Teenage Fanclub, torneremo negli anni ’80 con uno dei gruppi che sono entrati nel cuore della gente come i Replacements e con il gruppo con cui giocavano un clamoroso derby a Minneapolis: gli Hüsker Dü. Ci sarà spazio anche per una nuova uscita molto attesa come il nuovo Sleaford Mods, per un artista tanto riservato quanto talentuoso che ci manca molto come Elliott Smith, per le suggestioni etniche dei Dirtmusic e per una piccola intrusione nel mondo del sampling e dell’hip-hop. Il tutto sarà, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.
Intanto se volete potete sfruttare la parte riservata ai commenti qui sotto per darmi suggerimenti, criticare (perché no), o proporre nuove storie musicali. Mi farebbe estremamente piacere riuscire a coinvolgervi nella programmazione e nello sviluppo del mio sito web.
Se volete ascoltare o scaricare il podcast, potete farlo anche dal sito della PodRadio cliccando sulla barra qui sotto. Buon Ascolto
TRACKLIST
01. WEATHER REPORT: Birdland da ‘Heavy Weather’ (1977 – CBS)
02. TALKING HEADS: Psycho Killer da ‘Talking Heads: 77’ (1977 – Sire)
03. WIRE: I Should Have Known Better da ‘154’ (1980 – Harvest)
04. THE BLACK ANGELS: Comanche Moon da ‘Death Song’ (2017 – Partisan Records)
05. ALGIERS: Bite Back (Feat: Backxwash, Billy Woods) da ‘Shook’ (2023 – Matador)
06. RAMONES: Blitzkrieg Bop da ‘Ramones’ (1976 – Sire)
07. DEAD BOYS: Sonic Reducer da ‘Young Loud And Snotty’ (1977 – Sire)
08. PETE TOWNSHEND: Jools And Jim da ‘Empty Glass’ (1980 – ATCO Records)
09. THE WAEVE: Drowning da ‘The Waeve’ (2023 – Transgressive Records)
10. ELEGIAC: One Two da ‘Elegiac’ (2021 – Upp Records)
11. ANNA B SAVAGE: Say My Name da ‘In|Flux’ (2023 – City Slang)
12. BARK PSYCHOSIS: Blue da ‘Blue (12″)’ (1994 – Circa / 3rd Stone)
13. MOONSHAKE: Wanderlust da ‘Eva Luna’ (1992 – Too Pure)
14. MILES DAVIS: Miles Runs The Voodoo Down da ‘Bitches Brew’ (1970 – CBS)









