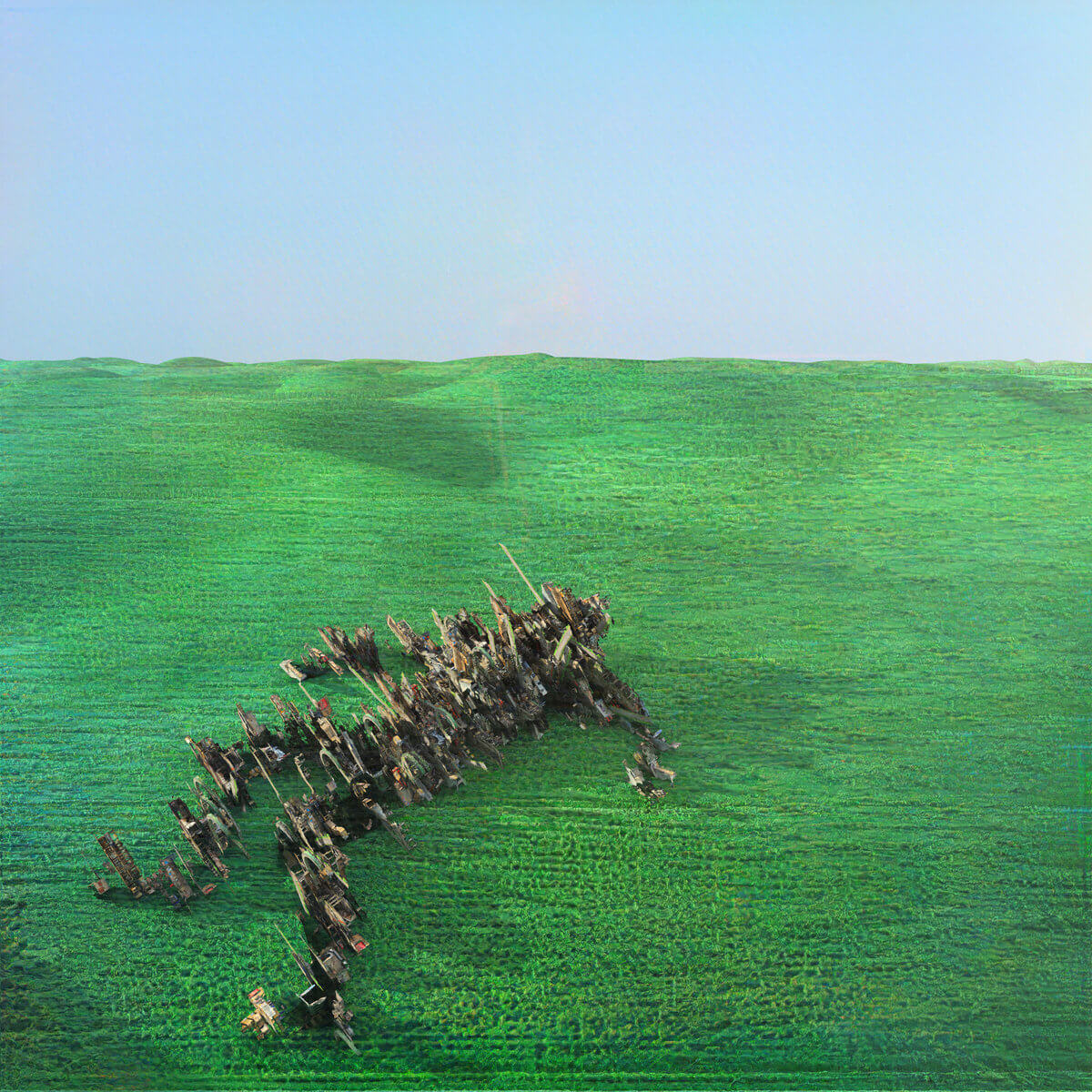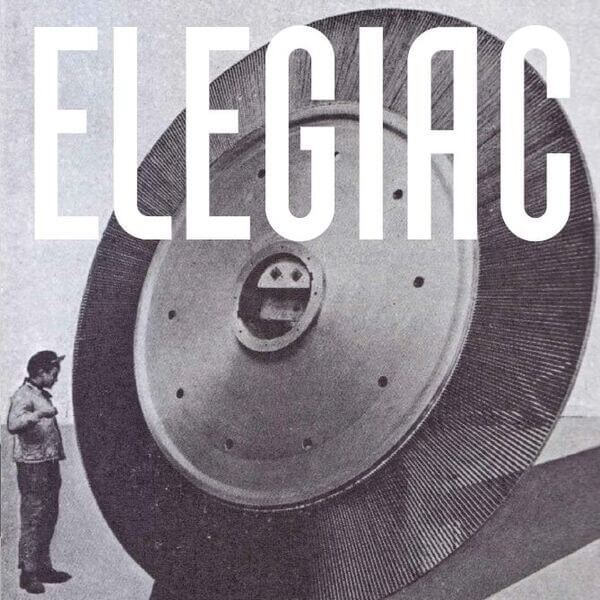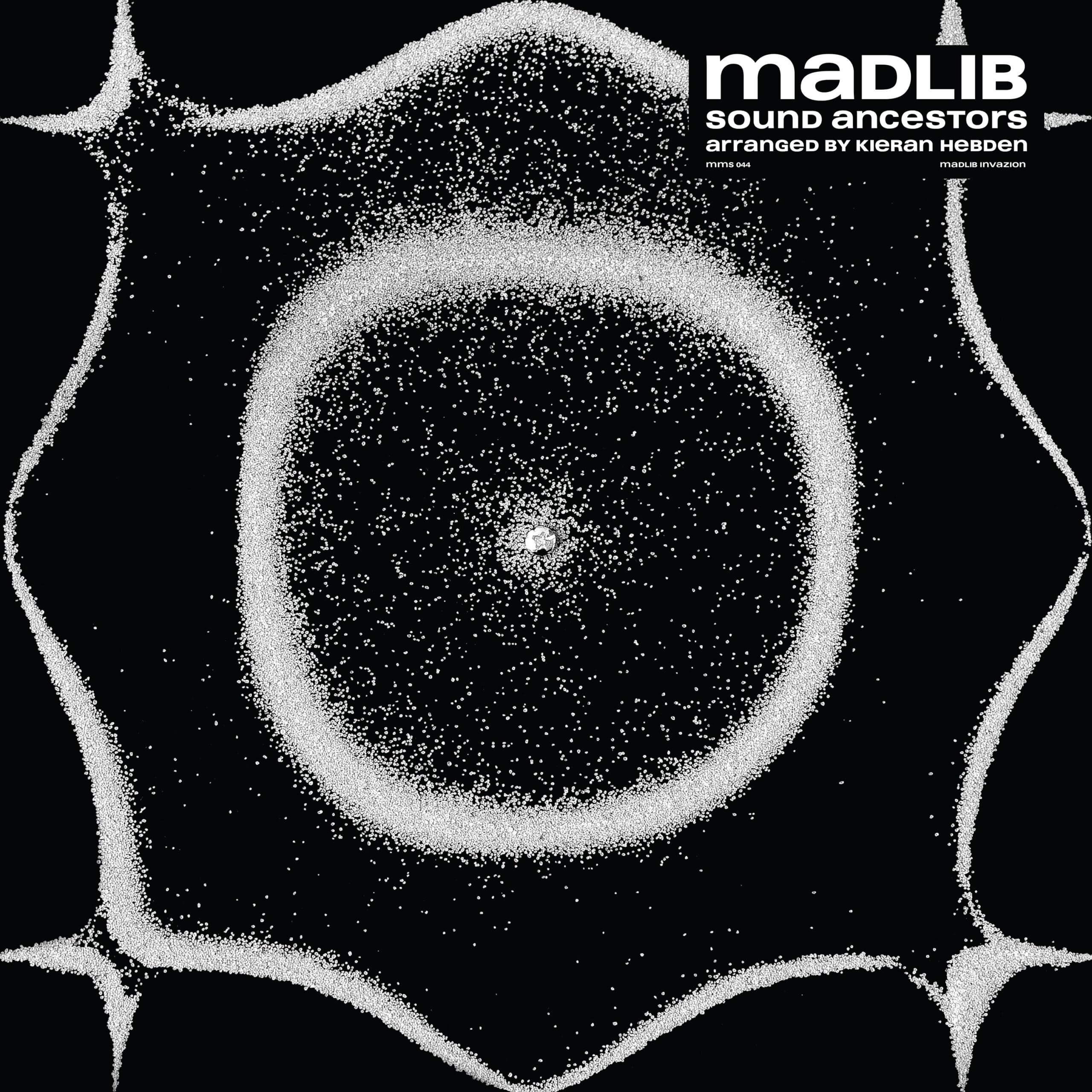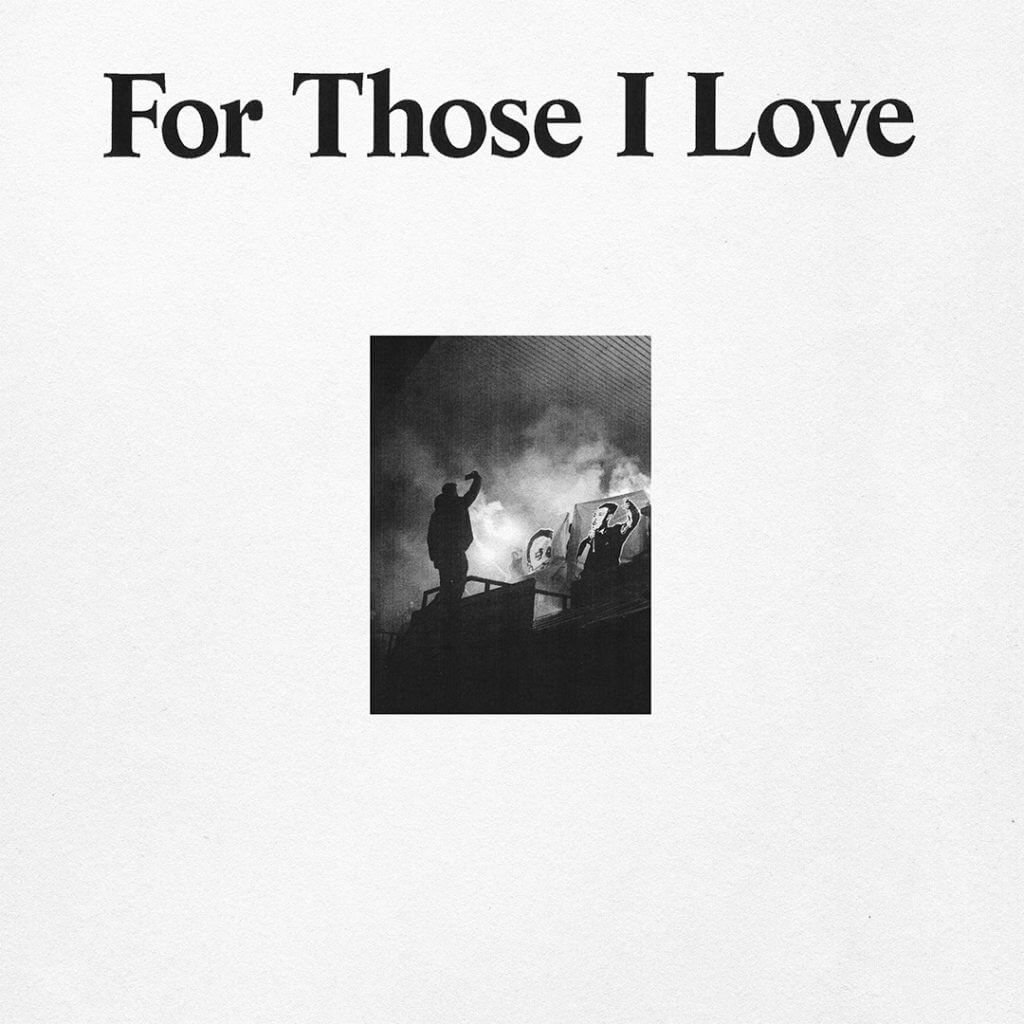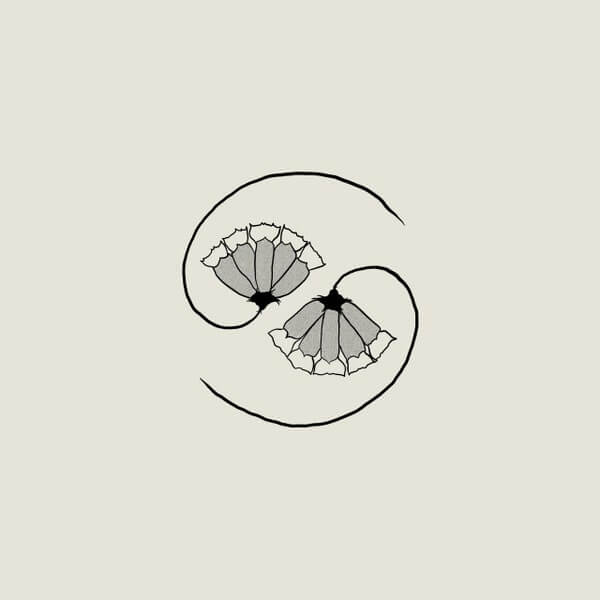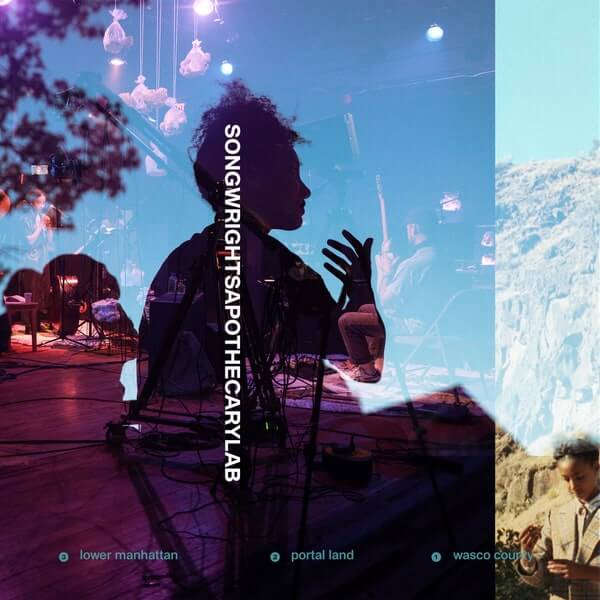Ecco il momento tanto atteso e temuto dell’anno, quello della compilazione dei migliori album usciti nel corso del 2021, ennesimo annus horribilis per questa maledetta pandemia che ha stravolto il nostro modo di vivere. Come ormai è chiaro da qualche anno, le modalità di ascolto della musica sono cambiate in maniera drastica: adesso possiamo trovare letteralmente tutto a disposizione, in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo. I servizi di streaming hanno giorno dopo giorno soppiantato sia la vendita dei cd che quella del download della musica “liquida”, lasciando la vendita del supporto fisico ai (quasi) soli appassionati, che sempre più spesso prediligono il caro vecchio vinile. Anche se alle volte il metodo barbaro di trasferire in vinile i master digitali rendono il formato in 12″ purtroppo di scarsa qualità.
Fare una classifica dei migliori album dell’anno, visto il numero gigantesco di uscite annuali, è un’impresa al limite del fantascientifico. Probabilmente a ragione, qualcuno lo considera anche un inutile esercizio di stile: difficile stabilire gerarchie, e soprattutto, fissare i “giusti” parametri da usare. Quali sarebbero? In base a cosa?
Impossibile ascoltare tutto, troppe le pubblicazioni e troppo poco il tempo quotidiano a disposizione per ascoltare nuova musica con l’attenzione che spesso meriterebbe. Ad esempio anche quest’anno ci saranno sicuramente alcuni album messi in fondo alla classifica che hanno avuto sicuramente la sfortuna di avere meno ascolti a disposizione e meno possibilità di essere apprezzati. Già gli ascolti sono giocoforza limitati, poi vengono filtrati attraverso la nostra particolare sensibilità, assecondando i gusti personali e la nostra attitudine musicale. Ma il tempo è tiranno e la realtà di Sounds & Grooves è davvero pochissima cosa (visto che sono l’unico a gestirla nella sua totalità) se paragonata a corazzate del mondo delle webzines musicali come OndaRock (con cui collaboro da qualche anno), SentireAscoltare dello stimatissimo Stefano Pifferi, Distorsioni, o gli splendidi blog personali di autentici giornalisti professionisti ed enormi conoscitori di musica come Eddy Cilìa, Federico Guglielmi o Carlo Bordone, tanto per citare i primi che mi vengono in mente.
In questo spazio, come quasi ogni anno, ho voluto semplicemente buttare giù, come appuntandoli su un taccuino, gli album che negli ultimi 12 mesi ho ascoltato di più, e che sono riusciti maggiormente a coinvolgermi, e condividere con voi la mia interpretazione, il mio modo di sentire. Nonostante ci siano un milione di classifiche sparse nel web, sia quelle compilate dalla varie (più o meno trendy) music webzines e magazines, che quelle postate sui vari profili personali dei social networks, credo che da ognuna di queste ci sia sempre da qualcosa da imparare, uno o più nomi da annotare per poi approfondire con curiosità.
In calce ai 50 album che più hanno segnato la mia annata musicale, troverete un’altra lista composta da outsiders, album che non sono entrati nella Top 50, sfiorando la mia personale eccellenza, ma che per molti di voi potrebbero invece essere (giustamente) degni della portata principale. Nei titoli che formano questa lunga lista, ce n’è per tutti i gusti. Nella playlist c’è spazio per le più svariate forme musicali: la classicità, l’indie-rock, il songwriting, il post-punk, i tradizionalisti, il rock classico, e perfino le musiche definite come avant-qualchecosa. C’è sempre un oceano di musica da scoprire, e molti (me compreso) non sono riusciti a rinunciare al fascino irresistibile dei tesori (o presunti tali) sommersi, avendo come risultato un’enorme varietà di nomi all’interno delle singole playlist.
Discorso a parte meritano le ristampe e quelle etichette (Light In The Attic, Superior Viaduct, Numero Group, Cherry Red tanto per citarne alcune) che hanno riportato alla luce o ampliato in maniera scintillante autentici capolavori, alcuni ripescati dall’oblio, altri semplicemente tirati a lucido. Ho compilato una piccolissima classifica anche delle mie preferenze in tal senso.
Ogni classifica dei migliori album dell’anno porta una scintilla per rinvigorire quella fiamma appassionata dentro ognuno di noi. Da parte mia un abbraccio speciale, consentitemelo, va sempre a quella che è la mia “famiglia” da sempre, prima in FM e poi sul web, ovverosia quella splendida podradio chiamata Radiorock.TO The Original.
#everydaypodcast
#1
ARAB STRAP As Days Get Dark (Rock Action)
As Days Get Dark (Rock Action)
Nel 1998 l’uscita di Philophobia degli Arab Strap gettò nel caos la piccola comunità scozzese di Falkirk. Alcuni piccoli e grandi segreti di alcuni dei 35.000 abitanti della città posizionata nella Forth Valley furono messi clamorosamente in piazza in maniera nuda, scarna, lenta e sofferta dalla voce narrante di Aidan Moffat e dagli arpeggi di Malcolm Middleton. L’esordio del duo scozzese era formato da canzoni malinconiche che parlavano di debolezze quotidiane, di sbornie, scopate e tradimenti. Canzoni che riescono ad arrivare dritte allo stomaco anche dopo tutti questi anni, visto che il disco è del 1998 e lo scioglimento del sodalizio scozzese risale al 2006. Nonostante i dischi solisti dei due ci abbiano regalato più di qualche gioia soprattutto i progetti solisti di Moffat a nome Nyx Nótt) ci mancava quella miscela di cinismo e sentimento, di depressione ed ironia che nella loro fortunata carriera insieme hanno saputo quasi sempre regalarci. La notizia del ritorno del duo nel 2016 ci aveva scaldato il cuore, ma, come sempre avviene sulle reunion dei gruppi che abbiamo amato molto, poi è subentratata la paura. Il timore della delusione, di non ritrovare gli stessi Moffat-Middleton. Ma già dalle prime note di As Days Get Dark si capisce che sono sempre loro. Dietro ad arrangiamenti perfetti e raffinati troviamo quella miscela di cinismo e sentimento, di depressione ed ironia che nella loro fortunata carriera insieme hanno saputo quasi sempre regalarci. Fortunatamente il ritorno dopo tanti anni non ha inficiato la capacità del duo di entrare emotivamente sottopelle narrando in maniera cinica ed emotiva la cruda realtà della vita di provincia. Bentornati!
Listen: The Turning Of Our Bones
#2
 ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP We’re OK. But We’re Lost Anyway. (Bongo Joe)
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP We’re OK. But We’re Lost Anyway. (Bongo Joe)
Se la sono giocata fino all’ultimo per la conquista della prima piazza, non l’hanno raggiunta ma mi hanno davvero entusiasmato e sono uno dei collettivi più interessanti degli ultimi anni. Un nome altisonante, una orchestra onnipotente il cui nome è un omaggio alle tante big band africane che usavano e usano questa definizione come biglietto da visita. Il nome Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è un modo per segnalarsi come gruppo freak e dadaista, un nome e un progetto su larga scala voluto dal contrabbassista Vincent Bertholet che ha creato il collettivo a Ginevra nel 2006. La prima idea era stata quella di metter su un gruppo rock in grado di usare la marimba e che potesse esibirsi in maniera sotterranea lungo tutto il continente europeo. Musicisti che con il post-punk come semplice base di partenza ma totalmente aperti ad una sperimentazione musicale in grado di avvicinare dub, punk, jazz d’avanguardia e rock in uno scambio aperto di suoni, di luoghi e di pubblico. Artigiani e irregolari, con una fortissima spinta propulsiva musicale e sociale, il gruppo piano piano diffonde il proprio verbo, si apre a mille interferenze, combinazioni e colori suscitando l’interesse anche di John Parish che nel 2014 si siede dietro al mixer per produrre Rotorotor, il loro terzo album. Dopo un altro (ottimo) lavoro uscito nel 2018 e ancora prodotto da Parish (Sauvage Formes), il gruppo ha ampliato la propria formazione a ben undici elementi (oltre al leader ci sono Liz Moscarola a voce e violino, Aida Diop alla marimba, Mael Salètes e Titi alla chitarra, Gabriel Valtchev e Guillaume Lantonnet alla batteria, Naomi Mabanda al violoncello, Thomas Levier alla viola, Gilles Poizat al bugle e Giff al trombone) e sostenuti da una spinta ideale tesa ad appoggiare chiunque voglia distruggere il capitalismo attraverso testi tanto poetici quanto sarcastici, da alle stampe We’re OK. But We’re Lost Anyway, dove afrobeat, folk, punk, jazz, Stereolab, kraut e vocazione spirituale in un flusso festoso teso ad esaltare la collettività e l’imprevedibilità. Nove irresistibili tracce per un album imperdibile.
Listen: So Many Things (To Be Guilty About)
#3
LOW Hey What (Sub Pop)
Tre anni fa, i Low sono tornati prepotentemente alla ribalta con Double Negative, un album che ci aveva preso alla gola e al cuore e strizzato l’anima, un buco nero capace di inghiottire tutto senza pietà. I detriti e schegge elettroniche, ormai inseriti in pianta stabile nel loro DNA, avevano nascosto tra i loro vortici una bellezza indicibile che anche su queste pagine aveva portato il disco in vetta alla classifica annuale. La cosa che aveva lasciato stupefatti critica e pubblico era pensare come Alan Sparhawk (chitarra e voce) e la sua consorte Mimi Parker (batteria e voce) ,dopo aver esordito nel 1994 con un capolavoro come I Could Live In Hope, fossero riusciti, a distanza di tanti anni, ancora a sorprendere. A distanza di tre anni, i coniugi di Duluth hanno lasciato (momentaneamente?) da parte il fido bassista Steve Garrington e hanno proseguito nel loro percorso sonoro che alterna manipolazioni tecnologiche a intense e celestiali armonie. Hey What non solo continua il percorso dei Low, ma lo aggiorna addirittura di versione. Il disco, che vede il confermatissimo BJ Burton in cabina di regia, mostra un suono ormai assestato. Non ci sono sorprese, e non potrebbe essere altrimenti, ma calibrati aggiustamenti di tiro, sempre però di enorme intensità e potenza. In questa incredibile ricerca di un miracoloso e ibrido equilibrio tra armonia e dissonanze, tra spasmi di feedback e voci eteree, tra gospel e risacche rumoristiche, tra slowcore e avanguardia, il duo di Duluth si muove cercando di mettere una sottospecie di ordine tra le macerie fumanti del disco precedente. Un paziente lavoro di sottrazione, di erosione alla ricerca di segreti nascosti, di perle scintillanti di indicibile bellezza che porta al concepimento di brani dove le voci di Parker e Sparhawk possano giocare con naturalezza e semplicità modulando vari contrasti di bianchi e neri e controllando le alternanze di rumore e melodie con una naturalezza e semplicità davvero incredibile. Con l’augurio che non possano mai smettere di emozionarci e sorprenderci, lunga vita ai Low: come non mai abbiamo bisogno di loro.
Listen: Days Like These
#4
FIRE! Defeat (Rune Grammofon)
Mats Gustafsson (flauto, sax baritono ed elettronica), Johan Berthling (basso) e Andreas Werliin (batteria, lap steel) sono arrivati con Defeat al quinto album (settimo se contiamo le collaborazioni con Jim O’Rourke e Oren Ambarchi) sotto il nome di Fire!, confermando la bontà della loro idea sonora. Nessuno come loro è riuscito a costruire aerodinamiche navicelle spaziali, riempirle di psichedelia, noise e kraut, e poi farle atterrare dolcemente su un pianeta dove la materia prima è l’improvvisazione jazz. Proprio quando sembravano aver perso un po’ della loro spinta propulsiva dopo il mezzo passo falso del precedente The Hands, i tre sono riusciti a dare una sferzata tanto improvvisa quanto imprevedibile al loro suono, portando Gustafsson a mettere da una parte il suo strumento di riferimento per dedicarsi quasi esclusivamente al flauto, e facendosi accompagnare da una piccola sezione fiati composta dai compagni di avventura nella Fire! Orchestra Goran Kajfes alla tromba e Mats Aleklint al trombone e sousaphone. I Fire! hanno, per fortuna, abbandonato subito la strada senza uscita di un coinvolgimento rock e doom per andare a riprendersi la loro modernità ripartendo dalle radici primitive. Enorme il carico di adrenalina e la vibrazione che rimane nell’aria anche quando si arriva a destinazione ed il silenzio ci circonda di nuovo. Enorme quanto la consapevolezza che la precisione chirurgica del basso di Berthling, l’eclettismo percussivo di Werliin, e la forza fisica e improvvisativa di un Gustaffson in stato di grazia sono tornati ad essere tra i più incredibili/credibili compagni in questa fantastica avventura che è la musica contemporanea. Non fatevi ingannare dal titolo, questo album è un trionfo.
Listen: Alien (To My Feet)
#5
RYLEY WALKER Course In Fable (Husky Pants)
Molte volte abbiamo parlato su queste pagine di Ryley Walker, un songwriter/chitarrista dell’Illinois capace con il suo talento di intraprendere un affascinante percorso partito da una perfetta integrazione della sua scrittura con il retaggio della scena folk britannica degli anni ’70. Dopo il successo di Primrose Green, Walker ha evidenziato degli album seguenti la splendida irrequietezza di un artista sempre in cerca di cambiamento. Nei i solchi dei suoi album possiamo trovare non solo tutte le influenze apertamente dichiarate durante l’arco della sua carriera, ma anche altre ispirazioni e riferimenti sempre nuovi oltre a mostrare una notevole personalità e unicità. Il tutto messo al servizio di una scrittura non facile ma sempre perfettamente a fuoco tra rilassamenti bucolici e momenti sperimentali, accordi aperti e accelerazioni sincopate improvvise. Un itinerario tortuoso, irrequieto, alla ricerca di una strada che sembra difficile da trovare, ma che all’improvviso appare in tutto il suo splendore davanti all’ascoltatore. Questa irrequietezza mostrata apertamente in musica purtroppo non ha risparmiato il Ryley Walker uomo. Nel 2018, dopo essersi trasferito a New York City, la sua dipendenza da alcool e droghe è arrivata ad un punto critico, costringendolo a chiedere aiuto e ad abbandonare le scene per un periodo di riabilitazione necessario visto il difficile stato fisico e psicologico in cui versava. La sua nuova vita è iniziata con la creazione della sua personale label chiamata Husky Pants Records è con un nuovo album, Course In Fable, prodotto da un personaggio cardine della storia recente di Chicago in musica come John McEntire. Il disco è lo specchio un artista che ha sempre voglia di progredire artisticamente, che si annoia facilmente e che è giunto in una fase di piena maturità artistica in cui riesce con disinvoltura a creare un incredibile e avventuroso equilibrio tra sperimentazione e struttura classica, riuscendo a non ripetere mai le stesse soluzioni. Sette brani dove è bello perdersi e ritrovarsi, mentre Walker si diverte a piazzare piccoli labirinti di complessità variabile da cui ne esce con sorprendente facilità grazie ad aperture armoniche e melodiche di tale bellezza liberatoria da togliere il fiato.
Listen: A Lenticular Slap
#6
SQUID Bright Green Field (Warp)
Questa nuova ondata di post-punk proveniente dalla Gran Bretagna sta raccogliendo allo stesso tempo consensi e critiche. Tre gruppi sembrano essere sotto l’occhio del ciclone per la loro proposta complessa e strutturata: Black Midi, Black Country New Road e Squid. Se per i primi la forma e la tecnica sembrano aver (purtroppo) sovrastato la parte emozionale, per Black Country, New Road e soprattutto Squid le cose sembrano essere diverse. Il quintetto capitanato dal batterista-cantante Ollie Judge nasce a Brighton nel 2017 ed il loro suono prende forma dall’amore per gruppi non certo convenzionali come This Heat, Talking Heads e Wire. Dopo alcuni singoli ed un EP usciti per la piccola etichetta Speedy Wunderground, è la Warp ad interessarsi a loro e a metterli sotto contratto. Il gruppo si trasferisce a Londra e fa uscire 5 interessantissimi singoli che acuiscono l’interesse degli addetti ai lavori, prima di pubblicare nel maggio 2021 l’attesissimo esordio Bright Green Field, prodotto magistralmente da Dan Carey. La band non mette affatto da parte il loro lato più emozionale. I saliscendi emotivi, le parti inquietanti e distopiche, i cambi di tempo repentini, tutto sembra (e probabilmente è) studiato alla perfezione ma quello che esce fuori dall’amplificatore ha la capacità di non risultare mai troppo tecnico, freddo e distante. “Global Groove” è il brano scelto per rappresentare una delle band più interessanti uscite nel 2021.
Listen: Global Groove
#7
SPACE AFRIKA Honest Labour (Dais Records)
Ogni tanto ci sono alcuni suoni provenienti dalla galassia elettronica che riescono a colpirmi in maniera particolare. Loro sono un duo chiamato Space Afrika, che con l’album Honest Labour sono riusciti a modificare la techno degli esordi per andare a creare un suono rallentato, rarefatto e notturno che prende qualcosa dal dubstep modificandolo in maniera personale. Joshua Inyang e Joshua Reid vengono da Manchester (anche se Reid adesso vive a Berlino), ed è proprio la città britannica ad essere immortalata nella copertina del disco, piovosa, notturna, illuminata dai lampioni e dalle luci delle macchine che si riflettono nella strada bagnata e sulla pensilina della “loro” fermata dell’autobus. Gli Space Afrika hanno messo a fuoco ben 19 tracce tanto frammentarie e varie nel loro spaziare emotivo dall’ambient all’industrial, dall’hip-hop al dubstep con parti cantate, featuring, archi e chitarre in sottofondo, quanto incredibilmente coeso nel messaggio musicale. Il titolo dell’album in realtà è un tributo a un membro della famiglia nigeriana di Inyang, che, per la sua lealtà era chiamato proprio Honest Labour. In realtà i due hanno sempre descritto il loro modus operandi creativo come “labour of love” per cui è possibile che il riferimento sia anche a loro stessi. Un disco notturno, ammaliante, coinvolgente, dove textures di suoni vanno sempre perfettamente al posto giusto.
Listen: Honest Labour
#8
ELEGIAC Elegiac (Upp Records)
Buffo che nelle pagine web italiane non ci sia praticamente spazio per Ted Milton. Eppure è un artista attivo già dagli anni ’60, prima come poeta, burattinaio e visionario, poi come sassofonista e fondatore dei Blurt, gruppo anarchico capace di unire post-punk e a no-wave con singulti jazz. Graham Lewis è sicuramente più conosciuto. Anche lui leader e outsider, bassista (e talvolta cantante) dalla mente brillante che ha contribuito non poco a rendere i Wire uno dei più grandi gruppi degli ultimi 50 anni di rock. Per formare una nuova band (che non sappiamo quanto sia un progetto estemporaneo o destinato ad avere un seguito) ai due si è aggiunto il compositore elettronico e sound artist Sam Britton, già capace in passato, insieme al cugino Ollie Bown, di farci rimanere a bocca aperte per le sue costruzioni sonore sotto il nome di Icarus. Come detto già nello scorso episodio, spesso e volentieri quando musicisti di questo calibro si uniscono, la somma delle parti ha spesso portato a cocenti delusioni se non a flop clamorosi. Ma fortunatamente, come nel caso degli Springtime, l’intelligenza e il talento di Milton, Lewis e Britton ha condotto i neonati Elegiac ad incidere uno dei dischi più interessanti e non allineati del 2021. Beats seducenti, spoken word, interventi di sax, innesti dub, il tutto frullato da tre musicisti dalla enorme personalità che rendono brani come la “One Two” che potete ascoltare qui sotto, come diamanti grezzi e dalla inestimabile suggestione. Il loro album eponimo è senza dubbio uno dei lavori più intriganti usciti negli ultimi anni.
Listen: One Two
#9
SPRINGTIME Springtime (Joyful Noise Recordings)
La parola “supergruppo” spesso fa rabbrividire, lo so. Nella quasi totalità dei casi, la somma della parti, anche nel caso di straordinari musicisti, hanno sempre portato cocenti delusioni se non flop clamorosi. Galeotta fu la pandemia, capace di bloccare in Australia il batterista Jim White (Dirty Three, Xylouris White), impedendogli di fatto il ritorno a Brooklyn dove vive da tempo. Di questa forzata “vacanza” australiana ha approfittato Gareth Liddiard (Tropical Fuck Storm, Drones), pronto ad invitare White in sala prove per provare qualche improvvisazione. Quando ai due si unisce il pianoforte di Chris Abrahams (The Necks, Benders, Laughing Clowns), si capisce che le vibrazioni e le tensioni tra i tre sono davvero importanti e stimolanti a tal punto che i musicisti per due settimane si chiudono in uno studio di registrazione isolato nello stato di Victoria per registrare (quasi in presa diretta) un intero album a nome Springtime. I tre dimostrano di essere perfettamente in sintonia nel dipingere sette tracce di lunghezza variabile, personali e nostalgiche, che talvolta mostrano l’angoscia per la vita durante la pandemia e che altre volte sanno essere poetiche grazie alle liriche (“Jeanie In A Bottle” e la drammatica “The Viaduct Love Suicide”) del poeta irlandese Ian Duhig, zio di Liddiard. C’è il jazz “altro” ma non è un disco jazz, c’è la tipica psichedelia australiana, c’è una cover dal vivo di Will Oldham, un traditional riarrangiato, una narrazione di morte, distruzione, desiderio e devozione. C’è un gruppo vivo e vitale, con un’inaspettata alchimia tra i componenti, che rende brani come “Will To Power” incredibilmente vitali, personali, travolgenti. iù sull’improvvisazione rispetto all’esordio, ma vi conquisterà.
Listen: Will To Power
#10
DAVID LANCE CALLAHAN English Primitive I (Tiny Global Productions)
Lo scoppio della pandemia ed il successivo lockdown hanno fatto trovare all’ex leader dei Moonshake (band cardine del post-rock britannico dei ’90) David Lance Callahan il tempo di mettere mano ad una serie di canzoni cui stava lavorando da molto e di scriverne delle nuove. Per dirla con le parole dello stesso autore “durante l’isolamento non c’era molto altro da fare se non recuperare i miei libri, filmare e scrivere canzoni”. Tutto questo ha portato l’inglese a registrare il materiale che compongono English Primitive (previsto in due volumi). A fine 2021 è uscito l’atteso esordio solista, e la prima parte di English Primitive non ha deluso le attese, mostrando un autore maturo e poliedrico, capace di mettere in musica la visione di una Gran Bretagna divisa, una reazione allo snobismo e ai fallimenti all’interno del sistema politico britannico. La scrittura è emozionante, cupa, sincera e schiacciante come non mai. Il disco non è un concept, ma a Callahan il titolo suonava bene in testa in quanto sembrava adattarsi al suo modo da “non-musicista” di comporre e suonare, e, più in generale, anche alla cultura e alla politica inglese che sembra aver toccato il fondo come nell’epoca post colonizzazione con la controversa gestione della pandemia e gli appalti di parti dell’NHS a compagnie private. La visione del mondo di Callahan è un po’ malinconica ma ottimista, espressa da una schiera di musicisti scelti con cura, come il sodale batterista Daren Garratt (Pram, The Fall, The Nightingales) e il trombettista e flautista Terry Edwards (amico di gioventù ed ex collaboratore dei Moonshake). Con questo album Callahan mostra a tutti il proprio talento di musicista e narratore che già avevamo visto ed apprezzato con Moonshake e The Wolfhounds, e il valore di queste sette tracce è talmente alto da farsi (quasi) perdonare l’inspiegabile trentennale silenzio che l’artista ha reiterato prima di rivelarsi come solista.
Listen: One Rainy September
#11
ANNA B SAVAGE A Common Turn (City Slang)
Non c’era alcun dubbio che la musica avrebbe avuto una parte fondamentale nella vita della londinese Anna B Savage. Figlia di due cantanti lirici, Anna ha trascorso i suoi primi compleanni nella stanza verde della Royal Albert Hall per una curiosa coincidenza: essere nata lo stesso giorno in cui morì Johann Sebastian Bach. Infatti ogni anno i suoi genitori venivano scritturati per esibirsi nell’annuale BBC Prom dedicato al compositore tedesco nella storica location di South Kensington. Dopo una silenziosa gavetta, nel 2015 la Savage ha pubblicato il suo primo EP, un’uscita prodotta da DM Stith accompagnata da poche e scarne note, ma capace di colpire nel segno per la timbrica profonda e per i testi personali che esprimevano insicurezze, domande e dubbi spesso irrisolti. Il passo successivo lo ha compiuto grazie al contatto e alla conseguente sinergia con William Doyle (FKA East India Youth) che, con la sua produzione ambiziosa ma elegante, è riuscito a dare una forma compiuta alle canzoni. I due sono stati in grado di creare A Common Turn, un disco composto da dieci tracce non certo convenzionali, piene di improvvise quanto felici intuizioni, dove l’estensione ed il timbro vocale della Savage riescono a creare intrecci con le armonie estremamente originali. Sono le vulnerabilità di ognuno di noi, più o meno nascoste, quelle che ritroviamo espresse con sussurri e potenza nelle 10 tracce di questo disco di disarmante sincerità fatto di tensioni e rilasci, ansie e catarsi. Non possiamo sapere come proseguirà la sua carriera, fare previsioni in campo musicale è sempre estremamente difficile e spesso si va incontro a brutte figure, ma questo è senza dubbio un esordio ammaliante.
Listen: Dead Pursuits
#12
MADLIB Sound Ancestors (Madlib Invazion)
Nato a Oxnard, California, Otis Jackson Jr. in arte Madlib era destinato a far musica: suo padre è stato un cantante e un musicista jazz e soul, sua madre suonava il pianoforte. I Jacksons, da sempre, si sono interessati non solo ad eseguire ma a studiare la storia della musica nera. Molti esponenti storici del jazz e soul afroamericano sono transitati dal cortile di casa Jackson: dal trombettista Jon Faddis, a Dizzy Gillespie, fino a Dee Dee Bridgewater. Ma il futuro Madlib non è mai stato interessato a fare musica in modo convenzionale. Nonostante passasse molto tempo a suonare il pianoforte e ad imparare i primi rudimenti di batteria, lui ha sempre trovato affascinante soprattutto la modalità di realizzazione di un disco. L’annuncio della collaborazione con Kieran Hebden, il produttore elettronico meglio noto come Four Tet, ha stupito molti, non essendo una modalità di lavoro usuale per il beatmaker californiano. Stavolta non è stato lui ad ascoltare, tagliare e modificare le registrazioni altrui, ma, come in un gioco di specchi, ha voluto aprire i suoi archivi lasciando che qualcun altro lavorasse sui suoi beat. Four Tet ha curato, modificato, assemblato e arrangiato 16 tracce scelte tra le centinaia di registrazioni che Madlib gli ha inviato negli ultimi due anni. L’instancabile curiosità di Madlib per le esplorazioni sonore ha trovato in Four Tet uno splendido terminale offensivo, facendo diventare un possibile difetto come la mancanza di direzione precisa, uno straordinario punto di forza. Gli arrangiamenti di Hebden si sposano con la sensibilità di Madlib in un caleidoscopio sonoro che va ad integrare le mille sfaccettature della cultura afroamericana del californiano con le modalità e le influenze etniche del britannico. Sound Ancestors è un album che si svincola completamente dalle logiche di mercato, facendoci navigare in un universo di riferimenti che è bello scoprire poco a poco.
Listen: Dirtknock
#13
SLEAFORD MODS Spare Ribs (Rough Trade)
Per voi malcapitati che seguite i miei podcast su Radio Rock The Original non sarà affatto una sorpresa la mia predilezione per gli Sleaford Mods. Sulla loro forza rabbiosa mi sono espresso più di una volta. Da qualche anno il duo punk-hop di Nottingham formato da Jason Williamson e Andrew Fearn ha firmato per la storica etichetta britannica Rough Trade senza perdere un grammo della loro ferocia sociale. Dal vivo poi sono assolutamente divertenti, più Williamson si danna, sbraita, inveisce, si avvita su se stesso, urla con il suo accento improponibile del nord dell’inghilterra, più il suo compare se la sghignazza bevendo birra e semplicemente facendo partire e stoppando le sue basi sul laptop. Spare Ribs è il loro undicesimo album in studio, profondamente ispirato dalla questione pandemica e, come sempre, dalla situazione politica britannica che fornisce sempre a Williamson spunti intriganti per i suoi testi. La loro formula è ormai facilmente identificabile, ma la semplicità con cui i due la fanno evolvere rimanendo fedeli a loro stessi è meravigliosamente spaventosa. In “Shortcummings” i due si scagliano contro uno dei grandi sostenitori della Brexit come Dominic Cummings, mentre la novità è che Amy Taylor degli Amyl and the Sniffers e Billy Nomates sono ospiti più che gradite in due delle tracce più accattivanti del disco. Pur non essendolo nel suono, nessun gruppo incarna meglio di loro la vera essenza del punk, e sono in pochi a poter vantare livelli così qualitativamente alti al giorno d’oggi.
Listen: Nudge It (Ft. Amy Taylor)
#14
DIVIDE AND DISSOLVE Gas Lit (Invada Records)
Un disco che colpisce per impatto musicale e sociale. Gas Lit è il terzo disco pubblicato dalla sassofonista e chitarrista Takiaya Reed che insieme alla batterista e percussionista Sylvie Nehill formano un duo chiamato Divide And Dissolve. Le due musiciste vengono Melbourne, ma la loro provenienza etnica (Cherokee la prima, Maori la seconda) le ha portate ad esprimere in musica un linguaggio (curioso dirlo di un duo che fa musica esclusivamente strumentale) un estremamente potente, politico e sociale contro ogni tipo di discriminazione. “Gas Lit è la nostra lotta per la sovranità indigena, la liberazione dei neri e degli indigeni, la restituzione dell’acqua, della terra e delle terre indigene. Gas Lit lotta contro l’espropriazione del nostro popolo, della nostra terra, della nostra acqua e del nostro spirito. Gas Lit è una chiamata alla trasformazione e alla libertà. Gas Lit vuole contribuire a minare e distruggere il quadro coloniale suprematista bianco.” Queste le loro parole, trasformate in musica in un impeto potente di scuro e ipnotico doom/drone rituale e tribale. Ad accoglierle come si deve ci ha pensato Geoff Barrow (Portishead) che ha pubblicato il disco con la sua Invada Records. Una forza immensa, un assalto frontale che non può lasciare indifferenti.
Listen: Prove It
#15
ONE ARM Mysore Pak (Alara)
A volta la strada per la pubblicazione di un album può diventare davvero lunga e tortuosa se i primi tasselli del puzzle non vanno subito al posto giusto. Nel 1992, a Parigi, Rose-Laure Daniel (basso e voce), Isabelle Vigier (chitarra) e Marine Laclavère (batteria) danno vita al progetto One Arm prendendo il nome da un racconto del drammaturgo e poeta americano Tennessee Williams. Le tre ragazze fanno parte senza sosta della scena musicale post-punk e no wave parigina e europea prima di sciogliersi nel 1997. Un anno dopo, digerito l’abbandono della Vigier, la sezione ritmica della band decide di riprendere il progetto facendolo partire di nuovo con due nuovi compagni di avventura. Una strada apparentemente folle visto che i nuovi arrivati componevano anche loro la sezione ritmica di un gruppo appena sciolto, La Mâchoire. L’innesto della batteria di Dilip Magnifique e del basso di Rico Herry ha dato vita ad un ibrido e simmetrico quartetto: due donne, due uomini, due bassi e due batterie. Ma anche stavolta il destino volta loro le spalle, l’etichetta che doveva produrre il loro atteso esordio fallisce e i componenti della band si salutano tornando ad essere geograficamente distanti.
Bisognerà aspettare altri 15 anni per far si che qualcosa si muovesse di nuovo sul fronte One Arm. L’interesse della Atypeek Music ha portato la band a riprendere i vecchi demo, arricchirli, remixarli e trasformarli nella versione definitiva che troviamo nella loro prima uscita sulla lunga distanza, finalmente pubblicata ad inizio 2021, che prende il nome di un loro antico progetto alternativo: Mysore Pak. Due bassi, due batterie, samples, field recordings capaci di shakerare post-rock britannico anni ’90 (quella meravigliosa estetica sonora che faceva capo all’etichetta Too Pure), funk, krautrock, new wave e musica industriale in un calderone febbrile di grande effetto. I quattro musicisti hanno messo su un album di sicura suggestione, capace di colpire con complesse trame ritmiche che vengono costantemente trafitte dagli inserimenti ispiratissimi degli effetti e dalle bordate di suoni meravigliosamente organizzati. A questo punto non ci resta altro che ascoltare di nuovo il disco e sperare che non ci facciano aspettare altri 20 anni per un seguito.
Listen: Real
#16
BLACK COUNTRY, NEW ROAD For The First Time (Ninja Tune)
Come detto in precedenza, ci sono molte giovani band britanniche che si stanno mettendo in evidenza nel panorama musicale, facendo (a torto) abusare dell’etichetta “post-punk” sia il pubblico che gli addetti ai lavori. Siamo nel Cambridgeshire, Tyler Hyde (voce e basso), Lewis Evans (voce, flauto e sax), May Kershaw (voce e tastiere), Georgia Ellery (voce e violino), Charlie Wayne (batteria) and Luke Mark (chitarra), ex Nervous Conditions (band britannica scioltasi nel 2017) decidono di amalgamarsi e provare nuove strade e, con l’aggiunta dell’altro chitarrista Luke Mark, fondano i Black Country, New Road. La band, come detto in precedenza, non è certo assimilabile alla scena post-punk (ammesso che ce ne sia una…), e questo For The First Time, il loro esordio, vede sei tracce dalla durata variabile e molto distanti dalla forma canzone classica. A voler per forza trovare un’etichetta, sono più assibilabili a certi gruppi post-rock degli anni ’90, e sono accostati dai molti ai Black Midi, ma fortunatamente non sono così eccessivi e leziosi e non eccedono nel mero esercizio di stile. Ritmi circolari e reiterati, stop and go, aperture melodiche e momenti di stasi improvvisi, tante suggestioni insieme che rendono il disco estremamente interessante e ci rende curiosi sul come i giovanissimi ragazzi britannici potranno sviluppare il loro suono e la loro carriera. Per adesso godiamoci un lavoro che sembra davvero molto interessante.
Listen: Athens, France
#17
ROSE CITY BAND Earth Trip (Thrill Jockey)
Ripley Johnson è un musicista americano noto per far parte dei rockers psichedelici Wooden Shjips. ma è anche un personaggio irrequieto e dalle mille sfaccettature, per cui dopo aver formato i Moon Duo insieme a Sanae Yamada lasciando scorrere un po’ di sangue kraut nelle sue vene, si è lasciato andare ad una carriera solista parallela dove poter sfogare tutta la sua passionaccia per il country rock. Nascosto dietro al nome di Rose City Band, Johnson si è rifugiato nella sua casa di campagna vicino Portland per registrare l’atteso seguito del già ottimo Summerlong uscito l’anno scorso. Quello che contengono le 8 tracce di questo nuovo Earth Trip è già chiarissimo dalla copertina, dove il ritratto di un rurale e solitario Johnson campeggia appeso ad una parete di legno. Mixato da uno splendido Cooper Crain (Cave, Bitchin’ Bajas), l’album mostra una meravigliosa capacità di scrittura, con la chitarra a viaggiare facendosi tutt’uno con la natura. Un disco fuori dal tempo, con le venature psichedeliche di Johnson ad aggiornare la voce country rock ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio nel tempo e nella natura, un album interpretato con passione, raffinato e creativo, che conferma Ripley Johnson come autore ed interprete di elevatissima fattura pur nella semplicità della scrittura.
Listen: In The Rain
#18
DRY CLEANING New Long Leg (4AD)
Abbiamo parlato in precedenza della scena post-punk inglese, mettendo l’accento soprattutto su alcuni collettivi che fanno dell’abilità strumentale e della complessità strutturale i loro punti di forza. Come molte bands coeve (Goat Girl, Shame, Fat White Family), i Dry Cleaning nascono nel sud di Londra dall’incontro alla Royal College of Art tra il chitarrista Tom Dowse e la cantante Florence Shaw. Qualche anno più tardi la formazione si consolida grazie all’innesto di Lewis Maynard (basso) e Nick Buxton (batteria) e alla pubblicazione di due EP ottimamente recepiti da pubblico e critica. La forza del collettivo si misura nelle scorribande chitarristiche che richiamano nomi importanti del passato come Gang Of Four, e nel cantato recitativo e apparentemente abulico di Florence Shaw. L’attesissimo album di esordio si intitola New Long Leg ed è prodotto da un personaggio importante come John Parish. Se il modo di cantare quasi recitativo e della Shaw risulta in qualche modo spiazzante, il modo in cui si integra con le taglienti intuizioni del resto del gruppo risulta estremamente interessante e fornisce al quartetto un passaporto di quasi unicità all’interno del movimento post-punk britannico. La title track inserita nel podcast è una delle tracce in cui questo meccanismo funziona meglio, ma la conclusiva “Every Day Carry”, con i suoi synth e le ambientazioni quasi krautrock, potrebbe fornire nuovi sbocchi estetici alla band. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro e se i quattro ragazzi riusciranno a non deludere le aspettative.
Listen: Scratchcard Lanyard
#19
FOR THOSE I LOVE For Those I Love (September Recordings Limited)
Due ragazzi cresciuti insieme nelle comunità operaie del nord di Dublino, un’adolescenza condivisa, un’amore per la musica esploso e corrisposto, una band, i Burnt Out che nel 2016 ha lisciato di poco quell’esplosione che qualcuno chiama post-punk e che ha investito Inghilterra e Irlanda poco più tardi. Uno di questi ragazzi, David Balfe, coinvolto da questo amore per la comunità di amici fraterni cui apparteneva e soprattutto dal legame che lo univa al leader della band, Paul Curran, aveva avuto l’idea di registrare un album che ruotasse proprio su questi sentimenti fortissimi consolidati negli anni. Nel 2018 il suicidio di Curran cambia completamente le carte in tavole e ribalta un intero piano di esistenza. Balfe elabora il lutto continuando a lavorare sul progetto, naturalmente cambiandolo in corsa, intitolandolo For Those I Love e rendendolo disponibile su Bandcamp solamente ad amici e familiari. Un disco dove vengono svelati i sentimenti più intimi, le dinamiche della violenza delle gang del loro quartiere cui avevano dovuto assistere da piccoli, e alla forza dell’unione per uscire da morte, dolore e dal rifiuto delle droghe più economiche come momentanea scorciatoia per uscire da tutto quello. “I have a love, and it never fades”, queste le prime parole recitate da Balfe, parole che campeggiano sul supporto fisico. Eh sì, alla fine l’autore ha acconsentito alla pubblicazione del disco in formato fisico, richiesta da Ash Houghton, un A&R della September Records rimasto folgorato dalle tracce. Questa richiesta ha trovato l’appoggio della famiglia di Curran e dei loro amici comuni, pronti ad esortare Balfe a condividere il progetto con il mondo. Un disco dove Balfe, che deve convivere con l’assenza della sua metà, travolge tutto come un fiume in piena nel ricordo di una persona con cui aveva condiviso tutto il suo mondo e sperato in un futuro migliore. Ad accompagnare il flusso di parole, c’è un’elettronica ora cupa, ora melodica, ora quasi trance ma talvolta vicina al dubstep. Un’ode ai loro amici e alla loro famiglia, a tutte le persone che amava: l’adolescenza difficile, il senso di appartenenza, l’amicizia così forte da poter schiacciare tutto, e poi il senso di colpa per quella morte così improvvisa e lancinante. For Those I Love è un disco potente, evocativo, sentimentale, catartico, sorprendente, dove è impossibile scindere la musica dalle emozioni.
Listen: I Have A Love
#20
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR G_d’s Pee AT STATE’S END! (Constellation)
Il collettivo di Montreal Godspeed You! Black Emperor, dopo qualche anno di pausa, è fortunatamente tornato ad incidere con frequenza quasi regolare. Anche per quanto riguarda il settimo lavoro in studio G_d’s Pee At State’s End!, uscito da pochi mesi, non viene certo a mancare il fascino ipnotico, epico, senza compromessi di una band che sin dall’indimenticabile esordio F#A#∞ del 1997 ha saputo trovare una formula unica composta da cavalcate eroiche che si innalzano al cielo come la bandiera che i GY!BE riescono a tenere sempre alta incuranti del vento che cambia. Il loro suono senza compromessi non cambia di una virgola, mantenendo sempre la stessa evocativa potenza. Stavolta, registrando a distanza in piena pandemia, il collettivo canadese ha anche voluto stilare una sorta di agenda sociale che ha come (quasi) unico obiettivo il capitalismo. L’introspettiva, tormentata e e claustrofobica “Our Side Has To Win (For D.H.)” è la traccia che forse meglio rappresenta questa sorta di concept politico e sociale. Un disco che consolida l’enorme potenza e l’indomita classe dei canadesi.
Listen: Our Side Has To Win (For D.H.)
#21
LAMBCHOP Showtunes (City Slang)
I Lambchop sono un gruppo attivo da ben 30 anni, che riesce anno dopo anno ad essere incredibilmente sempre unico pur cambiando ogni volta. Solo quel diavolo di Kurt Wagner, con la sua capacità di scrivere canzoni meravigliosamente senza tempo poteva farmi apprezzare addirittura una delle invenzioni più atroci della storia della musica: il vocoder, usato sia nel 2016 in FLOTUS (acronimo di For Love Often Turns Us Still), che nel 2019 in This (Is What I Wanted To Tell You), dove il nostro riesce a spargere emozioni pur flirtando in modo evidente con l’elettronica glitch. La maestria assoluta di Wagner nella scrittura di splendenti meraviglie, tra bassi pulsanti, archi sospesi nel cielo e il pianoforte a tinteggiare il tutto, si dispiega prepotente anche in questo breve Showtunes, dove Wagner ha voluto ancora una volta sperimentare qualcosa di nuovo, prendendo semplici tracce di chitarra e convertendole in tracce midi di pianoforti, ha scoperto improvvisamente che poteva “suonare” il piano, riuscendo ad arrangiare accordi e melodia senza i limiti che aveva con i suoi precedenti metodi di scrittura con la chitarra. La rimozione di queste limitazioni ha portato a un nuovo suono sorprendente, qualcosa di simile al primo Randy Newman o alle atmosfere di George Gershwin. Una sorta di nuova versione dei Lambchop, con CJ Canerieri alla tromba e James McNew degli Yo La Tengo al basso, che mantiene inalterata la magia di un gruppo che anno dopo anno non smette di affascinare ed emozionare.
Listen: Drop C
#22
SONS OF KEMET Black To The Future (Impulse!)
Uno dei motori di una sorta di rinascita di una multiforme materia jazz è senza dubbio il sassofonista Shabaka Hutchings, da solo o in una delle sue mirabolanti trasformazioni: The Comet Is Coming, Shabaka and the Ancestors o Sons Of Kemet. Un jazz multiforme che, come quello di Damon Locks di cui parleremo tra poco, esprime una forte connotazione sociale e politica. King Shabaka, accompagnato da Theon Cross (tuba) e la coppia di batterie formata da Tom Skinner e Edward Wakili-Hick, con questo nuovo Black To The Future già dal titolo esprime una precisa volontà, quella di “ridefinire e riaffermare cosa significa lottare per il potere nero”, come e più del precedente Your Queen Is A Reptile. Non a caso l’album inizia e finisce con gli spoken word dell’attivista Joshua Idehen. Un album coinvolgente e impegnato, dove è presente la rabbia proveniente dal movimento Black Lives Matter, e dove l’afro-beat si mescola splendidamente con le sonorità caraibiche tipiche di Hutchings. Le voci di Camae Ayewa aka Moor Mother e di Angel Bat Dawid (che ritroveremo anche dalle parti di Damon Locks), insieme al rap di Kojey Radical rendono ancora più forte e urgente una musica ed una lotta che non deve mai rimanere sopita. Un altro splendido lavoro da parte di questo straordinario e prolifico musicista.
Listen: Pick Up Your Burning Cross
#23
OLIVIA BLOCK Innocent Passage in the Territorial Sea (Room40)
Chi mi segue da tempo sa bene che un certo tipo di elettronica e di elettroacustica non è certamente la mia cup of tea. ma allo stesso tempo quando certi album riescono a colpirmi, restano saldamente all’interno del mio cuore musicale. Come abbiamo visto molti dei dischi usciti nel corso dell’anno sono stati, giocoforza, influenzati dalla pandemia. Tra questi anche il nuovo lavoro della cinquantunenne compositrice Olivia Block, nata ad Austin, ma cresciuta (anche artisticamente a Chicago). Un passato nel circuito indie-rock, ma folgorata sulla via di Damasco dall’estro degli improvvisatori chicagoani, che hanno mutato il suo modus operandi che da quel momento si è rivolto verso installazioni sonore, esperimenti di field recordings e meraviglie elettroacustiche. Il suo nuovo Innocent Passage in the Territorial Sea è un album dominato da mellotron e field recordings, guidata anche dai funghi allucinogeni che, a suo dire, l’hanno aiutata durante il lockdown ad ascoltare i vari timbri, soprattutto quelli bassi, con tutto il suo corpo senza filtri. La pandemia come una storia distopica di fantascienza, un provare a mettere in musica la desolazione e l’isolamento del lockdown. L’album è un viaggio nelle emozioni, un tentativo di mettere in musica un surreale momento della vita. La lunga “Rivers In Reverse” che chiude l’album è un momento di enorme coinvolgimento sensoriale.
Listen: Rivers In Reverse
#24
ESPERANZA SPALDING Songwrights Apothecary Lab (Concord Records)
La contrabbassista statunitense Esperanza Spalding arriva con Songwrights Apothecary Lab al suo ottavo album in studio. L’obiettivo della musicista di Portland stavolta è di rendere il suo jazz spirituale in qualche modo curativo per corpo ed anima, obiettivo che in qualche modo non sorprende mentre stiamo tentando di uscire fuori da questa pandemia. La sua frequentazione con altri musicisti, vari terapisti e esponenti di varie specializzazioni mediche, l’hanno portata ad un metodo di composizione chiamato Formwela, che è anche il titolo di tutti i tredici brani in scaletta. L’album è presentato come “metà laboratorio di scrittura di canzoni, metà pratica di ricerca guidata cheriunisce musicisti e operatori di diverse discipline, come la musicoterapia, le neuroscienze, la musica nera americana, il sufismo e la musica carnatica dell’India meridionale, nello spirito di una guarigione radicale”. In realtà i dodici brani possono compattarsi in quattro movimenti da tre brani ognuno, liberi di espandere il linguaggio musicale da un jazz elettrico a movimenti spirituali che non non diventano mai stucchevoli. La Spalding insieme ai musicisti che hanno collaborato con lei in studio (tr cui la voce di Corey King ed un cameo di Wayne Shorter) ha creato un laboratorio viaggiante dove esprimere il suo linguaggio musicale variopinto e curativo, ambizioso ma riuscito.
Listen: Formwela 10
#25
MARC RIBOT’S CERAMIC DOG Hope (Northern Spy)
Musicista trasversale nel senso più bello del termine, il chitarrista Marc Ribot si è preso (giustamente) la scena con straordinarie collaborazioni, dischi solista e molti progetti diversi tra loro. A parte la collaborazione storica con Tom Waits, Ribot ha lavorato con Caetano Veloso, John Zorn, David Sylvian, The Lounge Lizards, Arto Lindsay, Medeski, Martin and Wood, Cibo Matto, Elvis Costello, Foetus, The Black Keys e moltissimi altri artisti. Ha formato il Marc Ribot Trio con il bassista Henry Grimes e il batterista Chad Taylor dei Chicago Underground, i Marc Ribot y Los Cubanos Postizos dove svela l’amore per la musica tradizionale cubana e i The Young Philadelphians per riscoprire il soul della città della Pennsylvania negli anni ’70. Il chitarrista del New Jersey lascia il segno anche con i suoi Marc Ribot’s Ceramic Dog, insieme al batterista Ches Smith e al bassista Shahzad Ismaily. La sua sei corde si dimostra, come sempre, capace di compiere quei movimenti trasversali tra mondi diversi che solo pochi riescono a care con naturalezza, passando con energia e passione attraverso l’avanguardia, il folk, il rock, il jazz e il funk. Hope è il quarto album del trio, uscito nel 2021 in cui Ribot ed i suoi compagni di avventura riversano in nove coinvolgenti tracce tutta la rabbia dovuta al lockdown e alla situazione pandemica in generale. Tra testi pungenti e costruzioni musicali ardite, il trio scatena in maniera irrefrenabile tutto il potente arsenale a propria disposizione. L’ennesimo centro pieno di una carriera straordinaria.
Listen: They Met In The Middle
#26
GOAT GIRL On All Fours (Rough Trade)
C’è questa nuova scena molto interessante nata nel sud della capitale britannica, da cui sono uscite fuori realtà estremamente interessanti come Fat White Family, Shame, Idles, Goat Girl e Dead Pretties. Nel corso degli ultimi anni, queste formazioni sono riuscite tutte ad ottenere un contratto discografico, creando qualcosa di nuovo per la scena musicale britannica: un nutrito gruppo di musicisti giovani concentrati sulla creazione di un personale suono guitar-oriented. Come detto, tra loro ci sono le Goat Girl, quartetto nato intorno ad un noto pub di Brixton chiamato The Windmill e che dopo il contratto con la storica Rough Trade e un interessante e ancora acerbo album di debutto si è trovato su un palco ad aprire l’ultimo (purtroppo) concerto dei The Fall prima della scomparsa di Mark E.Smith. La band è formata dalla cantante-chitarrista Clottie Cream (Lottie Pendlebury),dalla chitarrista L.E.D. (Ellie Rose Davies), dalla bassista Naima Jelly e dalla batterista Rosy Bones (Rosy Jones). Dopo l’esordio ben accolto dalla critica dove le quattro svisceravano le paure di una generazione e le difficoltà della vita urbana in periferia, a rallentare il loro percorso c’è stata una malattia non proprio semplice che ha colpito la chitarrista Elle Rose Davies (fortunatamente risolta a lieto fine), e il cambio di bassista che ha visto Holly Hole (Holly Mullineaux) sostituire Naima Jelly. Tutto questo a portato le quattro ragazze ad incidere un lavoro profondamente diverso dall’esordio, con influenze psichedeliche, un impianto post-punk mai troppo aggressivo e un impianto complessivo più riflessivo. Anche le liriche si spostano dall’attacco violento verso i Tories ad una maggiore intimità. Con On All Fours le Goat Girl ci hanno spiazzato, ma assolutamente in positivo.
Listen: Sad Cowboy
#27
DICTAPHONE Goats & Distortions 5 (Denovali)
Nel 2000 il polistrumentista belga Oliver Doerell (chitarra, basso, elettronica) ha trovato il perfetto partner nel berlinese Roger Döring (clarinetto e sax), che condivideva con Doerell l’amore per la musica belga degli anni Ottanta. Nel 2009 si è unito al duo il violinista Alex Stolze. Nel corso di questi due decenni di esistenza i Dictaphone hanno suonato in più di 20 paesi e partecipato a festival come Mutek, Transmediale, Unsound, Benicassim e altri. Il ritrovamento da parte di Doerell di un vecchio registratore a nastro in una stanza nascosta della sua dimora Berlinese è stato l’elemento scatenante e il filo conduttore di questo nuovo album intitolato Goats & Distortions 5. Un oggetto usato come strumento, un trio ormai affiatato nel creare atmosfere notturne, misteriosi, affascinanti, che vanno a lambire confini arabeggianti. Fiati, archi suoni, ed il registratore a nastro che si uniscono perfettamente in dieci tracce di enorme eleganza e suggestione, un’alchimia sonora che rende il trio come una delle realtà più intriganti (e nascoste) dei suoni che vanno dal jazz al glitch. La voce di Helga Raimondi in “Your Reign Is Over” rende ancora più affascinante e inafferrabile un suono davvero originale e intrigante. Un disco da ascoltare preferibilmente in cuffia di notte, perché è in quella dimensione che tutto si amplifica meravigliosamente e misteriosamente.
Listen: Island 92
#28
LINGUA IGNOTA Sinner Get Ready (Sargent House)
Non è facile avvicinarsi al vissuto e alla musica di Kristin Hayter, più conosciuta con il nome LINGUA IGNOTA. Un passato di violenze domestiche e vessazioni subite, un presente di artista capace di esorcizzare la rabbia e la vendetta tramite un suono industriale, potente ed una voce che si spinge ai limiti delle proprie possibilità. Due anni dopo Caligula, l’album che l’ha resa più nota, la Hayer torna sotto l’ala protettrice di Seth Manchester dietro al mixer e con due collaboratori come J.Manama al banjo e del polistrumentista Ryan Seaton. Il nuovo album Sinner Get Ready riflette il trasferimento di Kristin in Pennsylvania, e dell’ausilio dei collaboratori. Così la musica, pur mantenendo misticismo e solennità, è meno violenta e presenta una voce spesso raddoppiata. Come dicevamo, anche il trasferimento ha avuto la sua importanza visto che due delle nove tracce raccontano proprio vere storie del passato della Pennsylvania, come quella della citta fantasma di Centralia, bruciata e abbandonata, che diventa metafora delle condizione delle donne abusate e maltrattate, oppure “Pennsylvania Furnace” dove il racconto del 18° secolo di un fabbro che gettò i suoi cani in una fornace diventa pretesto per far consumare la vendetta agli animali uccisi. Come i miti assolvevano al compito di ammonire gli uomini a seguire gli insegnamenti di Dio, così Kristin ci avverte del male del mondo e di fare ammenda nel caso non lo avessimo già fatto. Un disco non facile, che a tratti può apparire disturbante, ma che risulta straordinariamente riuscito sia musicalmente che emotivamente. Sinner Get Ready dimostra l’evoluzione continua di una splendida artista che mette la propria anima a nudo ancora una volta.
Listen: PENNSYLVANIA FURNACE
#29
DAMON LOCKS & BLACK MONUMENT ENSEMBLE Now (International Anthem)
Se parliamo di viaggi, contaminazioni ed alchimie sonore, come non citare un personaggio come Damon Locks, che dopo un percorso da artista e musicista a 360 gradi (Trenchmouth, The Eternals), sublima la sua visione musicale con il Black Monument Ensemble ed incidendo per una delle etichette cardine della nuova, sublime, visione del jazz odierna: la International Anthem di Chicago. Now, il secondo album del gruppo, un disco importante per idee e contenuti, dove Locks mette in musica non solo le sue esperienze pregresse ma anche tutto il suo bagaglio di impegno nel sociale che lo ha portato a girare per le aree più degradate di Chicago, per le scuole, nelle prigioni, portando un messaggio di speranza e di uguaglianza. Il suo essere trasversale sui generi musicali dal gospel all’afrobeat, dal jazz al funk elettrico, il tutto trafitto dalle voci di vari attivisti afroamericani a sublimare una musica che scende in campo per un’uguaglianza sociale. Il tutto circondato da un collettivo aperto, su cui spicca il clarinetto strepitoso di Angel Bat Dawid. Un disco ipnotico e militante, che conferma non solo Damon Locks ma soprattutto la International Anthem come faro musicale e sociale in questi tempi oscuri.
Listen: NOW (Forever Momentary Space)
#30
RICHARD DAWSON & CIRCLE Henki (Thrill Jockey)
ichard Dawson è un artista che appartiene ad una categoria molto particolare e quasi in via di estinzione, quella dei songwriters un po’ stralunati, poco convenzionali. Basti pensare ad un Richard Youngs, o ad un Kevin Coyne, senza voler scomodare l’enorme talento di Kevin Ayers (Dawson potrebbe montarsi la testa), tanto per farvi capire come poter inquadrare un personaggio come il chitarrista di stanza a Newcastle, città dell’Inghilterra settentrionale non troppo distante dal terreno dove sorgeva Bryneich, regno britannico nato attorno al 420 d.C. che aveva ispirato il bardo nella composizione dell’album Peasant, che nel 2017 mi aveva assolutamente folgorato per l’abilità di Dawson nel raccontare le sue storie con una scrittura tanto potente e affascinante quanto oscura e poetica.
Curiosamente, due anni dopo Peasant, Dawson (descritto dal The Guardian come “Britain’s best, most humane songwriter”) è tornato con un album intitolato 2020 che apparentemente cambia le carte in tavola abbandonando il folk-rock sghembo del disco precedente in favore di un sound che strizza l’occhio ad una sorta di pop-rock (sempre contaminato e in equilibrio precario). In questa sua lucida follia il nostro eroe è tornato nel 2021 con un album in coabitazione con una band che teoricamente non potrebbe essere più distante dal songwriting di Dawson, ovverosia i Circle, gli alfieri dell’heavy metal finlandese. Il risultato è una specie di concept album sulla botanica (!) intitolato Heiki, dove i Circle abbassano i toni producendo una specie di folk rock psichedelico su cui Dawson sguazza producendo un suono più dinamico e diverso del solito. Il risultato è l’ennesimo disco ottimo.
Listen: Lily
#31 - #50
31. STEARICA: Golem202020 (Monotreme Records)
32. MARISA ANDERSON-WILLIAM TYLER: Lost Futures (Thrill Jockey)
33. VANISHING TWIN: Ookii Gekkou (Fire Records)
34. BIG RED MACHINE: How Long Do You Think It’s Gonna Last? (Jagjaguwar)
35. TV PRIEST: Uppers (Sub Pop)
36. LITTLE SIMZ: Sometimes I Might Be Introvert (Age 101 Music)
37. NICK CAVE & WARREN ELLIS: Carnage (Goliath Records)
38. MOIN: Moot! (AD 93)
39. SUMAC: May You Be Held (Thrill Jockey)
40. TIRZAH: Colourgrade (Domino)
41. NATURAL INFORMATION SOCIETY with EVAN PARKER: Descension (Out Of Our Constrictions) (Eremite Records)
42. MARISSA NADLER: The Path Of The Clouds (Sacred Bones Records)
43. WILLIAM DOYLE: Great Spans Of Muddy Time (Tough Love Records)
44. TROPICAL FUCK STORM: Deep States (Joyful Noise Recordings)
45. OLD TIME RELIJUN: Musicking (K)
46. IDLES: Crawler (Partisan Records)
47. MAURICE LOUCA: Saet El Hazz (The Luck Hour) (Sub Rosa)
48. CIRCUIT DES YEUX: -io (Matador)
49. PENELOPE ISLES: Which Way To Happy (Bella Union)
50. SHAME: Drunk Tank Pink (Dead Oceans)
OUTSIDERS:
- CHRIS ECKMAN: Where The Spirit Rests (Glitterhouse)
- THE BUG: Fire (Ninja Tune)
- JOHN GRANT: Boy From Michigan (Bella Union)
- JOHN MURRY: The Stars Are God’s Bullet Holes (Submarine Cat)
- THE WEATHER STATION: Ignorance (Fat Possum Records)
- AARON FRAZER: Introducing… (Dead Oceans / Easy Eye Sound)
- XENIA RUBINOS: Una Rosa (Anti-)
- BOBBY GILLESPIE and JEHNNY BETH: Utopian Ashes (Third Man)
- IOSONOUNCANE: IRA (Numero 1/Trovarobato)
- SAULT: Nine (Forever Living Originals)
- COLLEEN: The Tunnel And The Clearing (Thrill Jockey)
- BILLY BRAGG: The Million Things That Never Happened (Cooking Vinyl)
- LONELADY: Former Things (Warp Records)
- CLINIC: Fantasy Island (Domino)
- DROPKICK MURPHYS: Turn Up That Dial (Born & Bred Records)
- THE BEVIS FROND: Little Eden (Fire Records)
- SHACKLETON: Departing Like Rivers (Woe To The Septic Heart!)
- INJURY RESERVE: By The Time I Get To Phoenix (Injury Reserve)
- DERUGUTIENI: Dark Mondo (Voodoo Rhythm)
- BLACK MIDI: Cavalcade (Rough Trade)
RISTAMPE & ANTOLOGIE:
- CAN: Live In Stuttgart 1975 (Mute – Spoon Records)
- FAUST: Faust 1971-1974 (Bureau B)
- LAURA NYRO: American Dreamer (Madfish)
- JONI MITCHELL: Archives – Volume 2: The Reprise Years (1968-1971) (Rhino)
- THE JAZZ BUTCHER: Dr Cholmondley Repents: A-Sides, B-Sides and Seasides (Fire Records)
- THE WHO: The Who Sell Out – Super Deluxe (Polydor – UMC)
- CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG: Déjà Vu – Deluxe Edition, 50th Anniversary (Atlantic)
- MOSE ALLISON: The Complete Atlantic/Elektra Albums 1962-1983 (Strawberry)
- FRANK ZAPPA: Zappa ’88: The Last U.S. Show (Zappa Records)
- JOHN COLTRANE: A Love Supreme: Live In Seattle (Impulse!)