Un piccolo spazio per riscoprire grandi cose
I Fat White Family sono pericolosi, irriverenti, scabrosamente onesti, e tra i gruppi più incredibilmente vitali nel Regno Unito.
In questi giorni dove non ci muoviamo da casa se non per le necessità imprescindibili e in cui si alternano preoccupazione e speranza per questo nemico silenzioso che sembra essere ovunque intorno a noi, abbiamo però una grande opportunità. Sono giorni difficili, e speriamo irripetibili, ma che proprio per questo in qualche modo non vanno sprecati. Abbiamo l’opportunità di poterci riprendere in parte quel tempo che spesso ci è stato negato dai ritmi nevrotici della nostra quotidianità. In particolare abbiamo anche la possibilità di riscoprire e riascoltare meraviglie che da tempo non accarezzano i nostri padiglioni auricolari. Non possiamo prevedere quanto durerà questa situazione, per quanto tempo saremo costretti ad agire prevalentemente all’interno delle mura domestiche. La speranza che questi giorni possano essere il meno possibile mi ha convinto a mettere gli episodi di questa nuova rubrica chiamata Music Room in una semplice doppia cifra. Giornalmente su queste pagine ci sarà un’artista, un gruppo, una canzone, un’emozione da riscoprire, per combattere la noia e la paura con la bellezza. Cerchiamo di agire in maniera consapevole, restiamo a casa.
#andràtuttobene #iorestoacasa
Oggi nel piccolo grande spazio di Music Room parliamo di un gruppo sgradevole, “politically incorrect”, disordinato, anarchico, malato, sghembo (nell’accezione peggiore del termine) che a inizio 2014 mi ha talmente entusiasmato da farmi riscrivere a causa del loro album di esordio, la Playlist dell’anno appena concluso.
 Il disco in questione si intitolava Champagne Holocaust, disco uscito a nome The Fat White Family gruppo che ha in un outsider autarchico come Mark E. Smith (leader dei Fall) e nella furia espressionista dei Birthday Party alcune delle loro principali influenze; vengono dal sud di Londra ma si tratta in realtà un gruppo multietnico, capitanato dal cantante Lias Saudi e dal chitarrista Saul Adamczewski (gli altri membri sono Adam Harmer: chitarra, Joe Panucci: basso, Nathan Saoudi: tastiere, e Dan Lyons: batteria). Le loro stramberie non riguardano la componente strettamente musicale. Sono ormai numerosi gli aneddoti che li riguardano: si narra di strumenti prima affittati e poi venduti, di alcuni concerti cancellati senza alcun preavviso e di altri conclusi con Saudi completamente nudo coperto di olio e farina; per non parlare della ormai famosa data di Sheffield dove il frontman ha pensato bene di “espletare i suoi bisogni fisiologici” sul palco in segno di protesta contro i proprietari del locale colpevoli, a suo dire, di aver pagato la loro performance con 2 miseri drink a testa… Insomma, in breve tempo sono diventati un gruppo seguito e controverso, forse uno dei pochi veri casi musicali provenienti dalla capitale britannica, da tempo in cerca della “Next Big Thing”.
Il disco in questione si intitolava Champagne Holocaust, disco uscito a nome The Fat White Family gruppo che ha in un outsider autarchico come Mark E. Smith (leader dei Fall) e nella furia espressionista dei Birthday Party alcune delle loro principali influenze; vengono dal sud di Londra ma si tratta in realtà un gruppo multietnico, capitanato dal cantante Lias Saudi e dal chitarrista Saul Adamczewski (gli altri membri sono Adam Harmer: chitarra, Joe Panucci: basso, Nathan Saoudi: tastiere, e Dan Lyons: batteria). Le loro stramberie non riguardano la componente strettamente musicale. Sono ormai numerosi gli aneddoti che li riguardano: si narra di strumenti prima affittati e poi venduti, di alcuni concerti cancellati senza alcun preavviso e di altri conclusi con Saudi completamente nudo coperto di olio e farina; per non parlare della ormai famosa data di Sheffield dove il frontman ha pensato bene di “espletare i suoi bisogni fisiologici” sul palco in segno di protesta contro i proprietari del locale colpevoli, a suo dire, di aver pagato la loro performance con 2 miseri drink a testa… Insomma, in breve tempo sono diventati un gruppo seguito e controverso, forse uno dei pochi veri casi musicali provenienti dalla capitale britannica, da tempo in cerca della “Next Big Thing”.
 La principale ragione di questo entusiasmo, a parte l’attenzione dei media per l’attitudine off-stage (e saltuariamente anche on stage), è sicuramente la loro abilità nel miscelare elementi garage punk, influenze folk, spunti lisergici e manciate di lo-fi, e trasformare il tutto in un risultato tanto sbilenco quanto stranamente equilibrato, tanto dissacrante quanto orecchiabile. L’album in realtà era stato diffuso inizialmente solo attraverso la pagina Bandcamp del gruppo, ma la qualità della proposta e la “reputazione” del gruppo hanno poi lanciato Champagne Holocaust verso la distribuzione attraverso l’etichetta Trashmouth, con la sorpresa finale di trovarlo inserito in molte classifiche 2013 di webzines e riviste specializzate di oltremanica.
La principale ragione di questo entusiasmo, a parte l’attenzione dei media per l’attitudine off-stage (e saltuariamente anche on stage), è sicuramente la loro abilità nel miscelare elementi garage punk, influenze folk, spunti lisergici e manciate di lo-fi, e trasformare il tutto in un risultato tanto sbilenco quanto stranamente equilibrato, tanto dissacrante quanto orecchiabile. L’album in realtà era stato diffuso inizialmente solo attraverso la pagina Bandcamp del gruppo, ma la qualità della proposta e la “reputazione” del gruppo hanno poi lanciato Champagne Holocaust verso la distribuzione attraverso l’etichetta Trashmouth, con la sorpresa finale di trovarlo inserito in molte classifiche 2013 di webzines e riviste specializzate di oltremanica.
Come dicevo, l’album presenta una notevole varietà di stili: si parte con il suadente mantra di “Auto Neutron“, che si rivela essere una specie di carta moschicida, in cui il tappeto di tastiere, la chitarra distorta e le voci che si inseguono fanno in modo di aprire il sipario ed invitarci sul palco. Ma ad ogni passo le assi di legno scricchiolano sempre di più e quando l’organo si ferma si ha l’impressione di essere uno di quei personaggi dei cartoni animati cui segano in maniera circolare il pavimento sotto i piedi…che, inevitabilmente, cede mentre partono le campane ed il rock’n roll grezzo di “Is It Raining in Your Mouth?“ dove Saudi inneggia con voce strascicata al sesso orale praticato in macchina:
“five sweaty fingers on the dashboard…”
Non contento di questo, per 3 minuti e sotto una chitarra scordata usata a mo’ di banjo, ha anche il coraggio di biascicare un mantra paranoico chiedendo “Who Shot Lee Oswald?”:
“was it a secret government inside the American government?… Was it the Velvet Underground? Gimme the truth! Was it Bobby Davro?”
prima che parta una “Without Consent” splendida nel suo alternare ritmi tribali e umori lisergici. Il minuto e mezzo del rock sporco e dissonante di “Special Ape” è un irriverente intermezzo che serve a mescolare ancora le carte in tavola prima che parta la meravigliosa “Cream Of The Young”, una delle canzoni migliori del lotto, disordinata e trascinante con una chitarra quasi western a squarciare un tappeto di percussioni e tastiere. Ma non è finita, anzi: ci sono ancora l’attitudine garage rockabilly di “Wild American Prairie”, il folk ubriaco di “Borderline” ed il punk da strada di “Heaven On Earth” prima che arrivi a spazzare tutto “Bomb Disneyland”, inno esuberante che conclude i loro concerti, canzone con un testo tanto provocatorio quanto ai limiti (se non oltre) del buon gusto:
“all your kids are dead kids / all your kids are naked / in my mind”
A chiudere il cerchio ci pensa il country sghembo e dissonante di “Garden Of The Numb”, che nel testo non le manda certo a dire ad alcuni non identificati personaggi che cercano la gloria ad ogni costo nel mondo del music business:
“you’d sell your mother’s cunt to open doors…”
evocando così la lurida creatura che campeggia sulla copertina del disco: una caricatura di uomo con la testa di maiale ed un enorme fallo, impegnato a tenere nelle mani una falce ed un martello entrambi insanguinati. Grotteschi, estremisti, sfrenati, psicotici, viscerali: insomma in una sola parola IRRESISTIBILI! Una boccata di aria fresca che ci voleva nello stantio magazzino del rock attuale.
 A tre anni di distanza dall’esordio, ecco di nuovo i riflettori puntati sui Fat White Family. Nonostante sia passato del tempo dall’esordio, a parte di pubblico e addetti ai lavori continuano e venire in mente quasi più gli aspetti sgradevoli, politically incorrect e anarchici della band piuttosto che il loro indiscusso talento musicale.
A tre anni di distanza dall’esordio, ecco di nuovo i riflettori puntati sui Fat White Family. Nonostante sia passato del tempo dall’esordio, a parte di pubblico e addetti ai lavori continuano e venire in mente quasi più gli aspetti sgradevoli, politically incorrect e anarchici della band piuttosto che il loro indiscusso talento musicale.
Talento che aveva portato la band multietnica di Brixton, sud di Londra, capitanata dal cantante Lias Saoudi e dal chitarrista Saul Adamczewski (gli altri membri sono Adam Harmer: chitarra, Nathan Saoudi: tastiere, ed il nuovo batterista Jack Everett) sulla cresta dell’onda. La principale ragione di questo entusiasmo, a parte l’attenzione morbosa dei media, era stata sicuramente la loro abilità nel miscelare elementi garage punk, influenze folk, spunti lisergici e manciate di lo-fi, e trasformare il tutto in un risultato tanto sbilenco quanto stranamente equilibrato, tanto irriverente e dissacrante quanto orecchiabile. Il costante touring della band ha portato come effetto sia un costante miglioramento on stage quanto un proliferare di aneddoti riguardanti i loro eccessi sia sul palco che fuori.
 Questo clamore sulle loro torbide storie sembra quasi fatto ad arte per distogliere l’attenzione dal fatto che i componenti della band sono molto più intelligenti e preparati culturalmente di quanto loro stessi vogliano farci credere, non solo perché la copertina del primo singolo del nuovo album è volutamente ispirata da quella di 20 Jazz Funk Greats dei Throbbing Gristle, ma per tutta una serie di riferimenti e citazioni sia musicali che testuali che non possono lasciare indifferenti. Nel primo album si parlava di stupri, pedofilia e su come bombardare Disneyland, qui troveremo serial killer, fascismo e relazioni difficili che sfociano in cieca violenza. C’è la voglia sempre e comunque di stupire, di essere fastidiosamente repellenti, di irriverenza depravata, ma è voluta e razionale, mai stupidamente cieca, ed è li dove, piaccia o no, dove risiede la loro enorme attrattiva. Senza troppi giri di parole, Lias Saoudi e compagni hanno fatto centro anche con il loro sophomore album più scuro e claustrofobico dell’illustre predecessore, un disco che, nonostante il titolo, Songs For Our Mothers, mai e poi mai faremmo ascoltare alle nostre mamme, un album che stavolta esce per la loro personale etichetta, la Without Consent.
Questo clamore sulle loro torbide storie sembra quasi fatto ad arte per distogliere l’attenzione dal fatto che i componenti della band sono molto più intelligenti e preparati culturalmente di quanto loro stessi vogliano farci credere, non solo perché la copertina del primo singolo del nuovo album è volutamente ispirata da quella di 20 Jazz Funk Greats dei Throbbing Gristle, ma per tutta una serie di riferimenti e citazioni sia musicali che testuali che non possono lasciare indifferenti. Nel primo album si parlava di stupri, pedofilia e su come bombardare Disneyland, qui troveremo serial killer, fascismo e relazioni difficili che sfociano in cieca violenza. C’è la voglia sempre e comunque di stupire, di essere fastidiosamente repellenti, di irriverenza depravata, ma è voluta e razionale, mai stupidamente cieca, ed è li dove, piaccia o no, dove risiede la loro enorme attrattiva. Senza troppi giri di parole, Lias Saoudi e compagni hanno fatto centro anche con il loro sophomore album più scuro e claustrofobico dell’illustre predecessore, un disco che, nonostante il titolo, Songs For Our Mothers, mai e poi mai faremmo ascoltare alle nostre mamme, un album che stavolta esce per la loro personale etichetta, la Without Consent.
“Whitest Boy On The Beach” ha il compito di aprire l’album con il suo ritmo sostenuto e l’incedere surf accompagnato da chitarre e synth, un brano morboso ed appiccicoso, che già sappiamo non sarà il filo conduttore di tutto l’album, perché a loro piace destrutturare la forma canzone come nella migliore tradizione post-punk, ma con un eclettismo stilistico tutto nuovo. “Satisfied” è uno scuro carrozzone electroblues che si insinua e colpisce con una chitarra tentacolare e un testo che va a scomodare addirittura Primo Levi:
“My penis was an oblong pebble/ My balls two benevolent stones/ She looked like Primo Levi sucking marrow out of a bone / I’m so easily satisfied / And I am always hungry!!!”
Il brano è stato registrato a NY negli studi di Yoko Ono, suonato con gli strumenti appartenuti a John Lennon e prodotto dalla band insieme a Sean Lennon. Lo stesso Sean descrive così l’incontro ed il lavoro con la band nell’East Village di NY: “Sono caotici e fuori controllo. I Fat Whites hanno personalità estreme e sembra un miracolo che loro possono essere insieme nella stessa stanza. In ogni caso ho scoperto presto che le cose sono molto più piacevoli di come sembravano. La loro reputazione è reale, ma allo stesso tempo, non lo è.”
La seguente “Love Is The Crack”, come un lento e sghembo blues, pone l’accento (e non sarà l’unica volta), sul rapporto tormentato tra due persone, il “crack” cui si riferisce il titolo non è il tipo di stupefacente (come potrebbe sembrare conoscendoli), ma lo schioccare della frusta che implica un rapporto di sudditanza, amplificato dall’organo che chiude il brano. Il coro da condannati a morte che apre “Duce” mette i brividi, soprattutto quando parte una ritmica marziale ed una chitarra oscillante che inquieta e riecheggia a lungo.
“Eat the pope / Saving grace / Purity / All the way / He’s the one we’ve chosen / Him and no one else / Come boy Come girl Black shirt Black lace oh e ah / He’s the one we’ve chosen / Bleed for no one else”
La breve “Lebensraum” è una sghemba ballata folk/hawaiana che fa ciondolare la testa, mentre il successivo funkeggiante blues “Hits Hits Hits” riprende il tema delle relazioni difficili, narrando della complessa e violenta relazione tra Ike e Tina Turner, forse metafora del rapporto tra il maggiore dei fratelli Saoudi ed il chitarrista Saul Adamczewski.
“There’s a hatred in my bones / Just can’t live without / Sister Tina don’t be shy, patience is starting to bruise / Better spread that nutbush wide / What have you got to lose?”
“Tinfoil Deathstar” è una delle canzoni migliori del lotto con un organo spaziale, linee di basso rimbombanti e una voce psichedelica in falsetto che narra di visioni derivate dall’abuso di eroina, dove fa capolino anche il “morto di stato” David Clapson. E che dire di “When Shipman Decides?” Sotto una rassicurante ballad con i fiati a tener banco e un ritmo da luna park si nasconde in realtà il mondo del terribile serial killer britannico Harold Shipman, morto suicida in carcere dopo aver ucciso presumibilmente oltre 300 persone con l’uso della morfina. “We Must Learn To Rise” è una lunghissima e scurissima marcia, un vero inno con una tromba a fiancheggiarci per farci tenere il ritmo del passo, mentre la chitarra si rincorre impazzita nel finale garage e post-punk. A concludere il tutto ci pensa “Goodbye Goebbels”, un’altra ballata folk sghemba, quasi una filastrocca da cantare in coro dopo una sbronza tenendo in alto una pinta di birra al pub, se non fosse che la canzone parla degli ultimi istanti nel bunker di Hitler prima del suicidio del leader nazista.
Non è mai facile superare l’esame del secondo album, soprattutto quando le aspettative sono così alte, ma con Songs For Our Mothers, la band di Brixton lo passa a pieni voti. Il disco forse non è così immediato e coinvolgente come l’esordio, ma più maturo, consapevole, dove la band riesce a maneggiare il loro esplosivo materiale sonoro con grande aggressività, incurante del fatto che possa esplodergli tra le mani. Parlando dell’album, Saul Adamczewski ha detto: “Abbiamo davvero tentato di esplorare i limiti di cosa è di buon gusto. Prima che registrassimo il primo album, la gente ci faceva notare che usavamo molti stili differenti, il che non era intenzionale, ma allo stesso tempo mi piaceva molto l’idea. Io so che non stiamo cercando di spingere le cose oltre, so che non stiamo facendo nulla di innovativo. ma quello che riusciamo a fare bene, penso, è prendere vari pezzi qua e là – glam-rock, punk, psichedelia, folk, country – e riuscire a metterli tutti insieme. Ho realizzato che possiamo suonare qualsiasi tipo di musica; non siamo bloccati in un singolo genere. Questa è la mia cosa preferita della band.”
E forse anche la mia, oltre al fatto che sono pericolosi, irriverenti, scabrosamente onesti, e tra i gruppi più incredibilmente vitali nel Regno Unito.
 Come detto finora, nonostante la loro immagine spesso disgustosa e controversa, i Fat White Family sono senza dubbio uno dei gruppi più importanti partoriti negli ultimi anni dalla terra di Albione insieme a Sleaford Mods, Idles, Shame e più recentemente Fontaines D.C. Nel 2016 il loro secondo album Songs For Our Mothers aveva confermato la band multietnica di Brixton, sud di Londra, come una delle realtà più pericolose, irriverenti, scabrosamente oneste e incredibilmente vitali del Regno Unito. A due anni di distanza dall’uscita del disco, deve essere successo qualcosa che ha minato irreparabilmente gli equilibri di una band che non ha mai brillato per stabilità. Il cantante Lias Saoudi si è unito ai guastatori elettronici Eccentronic Research Council creando il gruppo mutante The Moonlandingz, mentre il chitarrista Saul Adamczewski dopo aver partecipato parzialmente allo stesso progetto, si è poi dedicato anima e corpo alla sua creatura solista Insecure Men insieme all’amico d’infanzia Ben Romans-Hopcraft.
Come detto finora, nonostante la loro immagine spesso disgustosa e controversa, i Fat White Family sono senza dubbio uno dei gruppi più importanti partoriti negli ultimi anni dalla terra di Albione insieme a Sleaford Mods, Idles, Shame e più recentemente Fontaines D.C. Nel 2016 il loro secondo album Songs For Our Mothers aveva confermato la band multietnica di Brixton, sud di Londra, come una delle realtà più pericolose, irriverenti, scabrosamente oneste e incredibilmente vitali del Regno Unito. A due anni di distanza dall’uscita del disco, deve essere successo qualcosa che ha minato irreparabilmente gli equilibri di una band che non ha mai brillato per stabilità. Il cantante Lias Saoudi si è unito ai guastatori elettronici Eccentronic Research Council creando il gruppo mutante The Moonlandingz, mentre il chitarrista Saul Adamczewski dopo aver partecipato parzialmente allo stesso progetto, si è poi dedicato anima e corpo alla sua creatura solista Insecure Men insieme all’amico d’infanzia Ben Romans-Hopcraft.
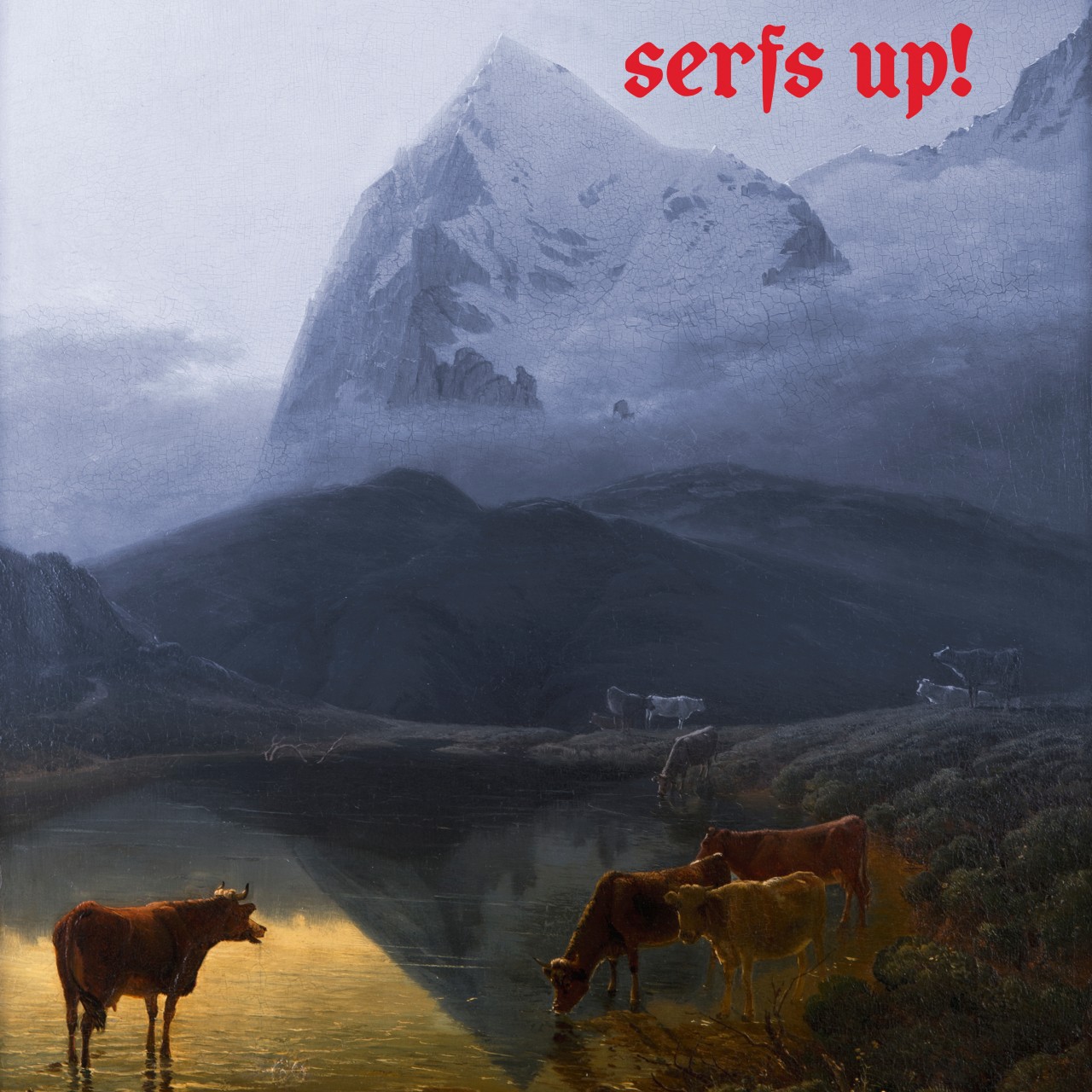 La gelida aria di Sheffield condivisa con The Moonlandingz deve essere piaciuta a Saoudi, perché proprio nel quartiere Attercliffe della grigia cittadina britannica ha deciso di stabilire il proprio fortino creando i Champzone Studios e cercando insieme al fratello Nathan l’ispirazione per poter stupire di nuovo. Dopo un difficile percorso di disintossicazione anche Adamczewski si è unito a loro. Nonostante la drastica riduzione numerica della band, il trio è riuscito a trovare una formula diabolica per cambiare pelle, e anche etichetta, visto che Serfs Up! è il primo album ad uscire per la Domino. Il nuovo album è stato registrato con l’aiuto del collaboratore di vecchia data Liam D. May, del sodale Ben Romans-Hopcraft, del sassofono di Alex White e della voce di Baxter Dury come meraviglioso ospite in “Tastes Good With The Money”. Proprio nel momento in cui l’approccio vincente sembra essere lo slancio aggressivo post-punk di Idles, Fontaines D.C. e Shame, i Fat White Family decidono di effettuare una sorta di dietrofront tra ritmi rallentati, sax, archi e quadretti “finto bucolici” che potrebbero sorprendere solo chi non conosce l’attitudine luciferina del gruppo. Alla fine dei conti, quello che poteva essere un clamoroso autogol si è trasformato invece in un inaspettato successo personale.
La gelida aria di Sheffield condivisa con The Moonlandingz deve essere piaciuta a Saoudi, perché proprio nel quartiere Attercliffe della grigia cittadina britannica ha deciso di stabilire il proprio fortino creando i Champzone Studios e cercando insieme al fratello Nathan l’ispirazione per poter stupire di nuovo. Dopo un difficile percorso di disintossicazione anche Adamczewski si è unito a loro. Nonostante la drastica riduzione numerica della band, il trio è riuscito a trovare una formula diabolica per cambiare pelle, e anche etichetta, visto che Serfs Up! è il primo album ad uscire per la Domino. Il nuovo album è stato registrato con l’aiuto del collaboratore di vecchia data Liam D. May, del sodale Ben Romans-Hopcraft, del sassofono di Alex White e della voce di Baxter Dury come meraviglioso ospite in “Tastes Good With The Money”. Proprio nel momento in cui l’approccio vincente sembra essere lo slancio aggressivo post-punk di Idles, Fontaines D.C. e Shame, i Fat White Family decidono di effettuare una sorta di dietrofront tra ritmi rallentati, sax, archi e quadretti “finto bucolici” che potrebbero sorprendere solo chi non conosce l’attitudine luciferina del gruppo. Alla fine dei conti, quello che poteva essere un clamoroso autogol si è trasformato invece in un inaspettato successo personale.
Ad introdurre il disco ci pensa il singolo trainante “Feet”, che con il suo ritmo anni ’80 tra archi, cori e voci filtrate ci fa capire subito che razza di mine vaganti siano diventati (o sono sempre stati?) i Fat White Family. Quando finisce la lunga coda strumentale tra echi mediorientali e chitarre dissonanti non c’è tempo per riflettere sul cambiamento stilistico della band perché le atmosfere ipnotiche di “I Believe In Something Better” sono lì appostate dietro l’angolo, pronte ad avvilupparci in un meticoloso e programmatico motorik. Che dire poi della ballata pop psichedelica “Vagina Dentata” (solo loro potevano scegliere un nome così…) capace di chiudersi frettolosamente per dare spazio ad un basso pulsante che rincorre i cori esotici e sgangherati di “Kim’s Sunset”. Non bastasse, beccatevi pure il quasi Prince sintetico della coinvolgente “Fringe Runner”, o gli archi beatlesiani alla “Eleanor Rigby” che introducono il bozzetto esotico “Oh Sebastian”.
Non siete ancora convinti? Allora ascoltate uno dei brani cardine di Serfs Up!, i Serfs del titolo non sono altro che i servi della gleba. “Tastes Good With The Money” è uno dei vertici dell’album: una sorta di bluesaccio malato suonato con passione come se i tre si fossero reincarnati nei T Rex dei vecchi tempi. A proposito della creatura di Marc Bolan, ditemi voi se il riff iniziale non vi ricorda quello di “Get It On”. Il brano è introdotto da un coro solenne ed è capace a metà della sua corsa di sfoderare lo spoken word di un Baxter Dury in gran forma nel suo recitare con tono profondo. Se vi capita, guardate qui sotto il video del brano, diretto da Roisin Murphy ed ispirato ai Monty Python e alla loro attitudine sarcastica ed irriverente. Gli inglesi che ridono di loro stessi, cantando mentre la situazione precipita in tragedia. Una perfetta rappresentazione della instabile e confusionaria politica britannica.
La dolcezza di “Rock Fishes” è solo uno specchietto per le allodole, perché il finale tra chitarre dissonanti ed esplosioni lascia spazio alle tastierine giocattolo di “When I Leave” che con uno stacco di chitarra spaghetti western ci fa impolverare per bene prima di blandirci ancora con la conclusiva “Bobby’s Boyfriend”, una ballata lenta e malata sia musicalmente che liricamente, capace di racchiudere in quattro minuti tutto il mood del disco.
Magicamente i Fat White Family sono riusciti in qualche modo a mutare il proprio DNA senza perdere il proprio appetito, con uno slancio pop che riesce a sorprendere, coinvolgere e soprattutto convincere. Sono sicuro che il loro nume tutelare, Mark E. Smith, starà sghignazzando lassù da qualche parte. Ad uno dei più interessanti, autentici ed irriverenti gruppi britannici degli ultimi anni non potevamo sinceramente chiedere di più.








